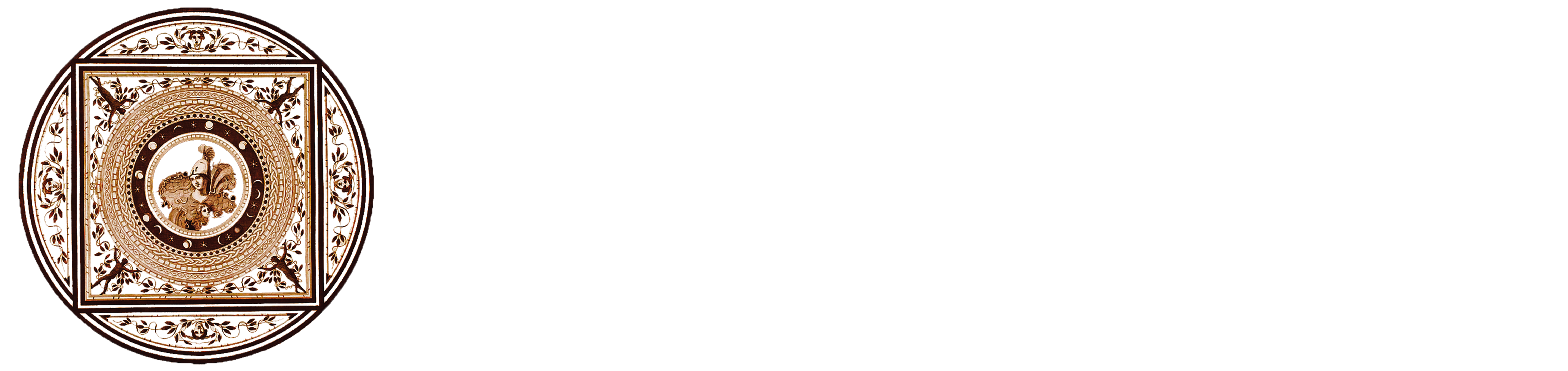Gli Atti dell’incontro sono pubblicati anche nella bacheca del del Dottorato di Antichità classiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata al seguente indirizzo:
http://dott.antichita.uniroma2.it/2022/04/19/seminario-storia-della-civilta-albana-e-dei-suoi-monumenti/
![]()
INTERVENTO INTRODUTTIVO DI FRANCO ARIETTI
L’intervento è assai articolato (vengono commentate 150 immagini) per cui in questa sede si presenta solo una sintesi degli argomenti trattati, in gran parte pubblicati su questo sito attraverso vari articoli di carattere divulgativo, dei quali si forniranno di volta in volta i rispettivi link (soprattutto per gli approfondimenti e le immagini)
PARTE
I
Storia degli studi e delle ricerche
Nel 1978 uno studio di Lawrence Richardson rilevò che la spectio dell’auguraculum dell’Arce capitolina venne orientata verso il Monte Albano. Poco dopo, si ipotizzò che anche tutti gli auguracula delle città latine fossero orientati verso il Monte Albano, il centro sacrale dei Latini, e venne sottolineata la maggior importanza di Giove Laziale rispetto allo stesso Giove Capitolino. Il grandioso massiccio vulcanico Albano domina la pianura laziale che lo circonda. Fin dalle origini, la sua storia è stata molto diversa da quella dei centri laziali di pianura che hanno sempre trovato nei Monti Albani un punto di riferimento politico e religioso. Dobbiamo chiederci perché e come la civiltà latina si è andata strutturando in questi luoghi. A cominciare dalla città madre di tutti i latini, Alba Longa, che la tradizione vuole abbia fondato le più importanti città latine, Roma compresa. Secondo le fonti antiche Alba Longa e il centro sacrale dei latini sul Monte Albano furono estranei tra loro perché appartenenti a due momenti diversi, mentre gli studiosi moderni li hanno sempre considerati separati anche a livello spaziale
Oggi la vetta del Monte Albano è stata devastata. Sotto la selva di tralicci, box e edifici abusivi c’è il tempio di Giove Laziale – che nessuno ha mai visto – e il tempio di Giunone Moneta, ugualmente mai trovato; accanto ad essi dovrebbero esserci vari culti precedenti, altari eccetera, come sempre avviene nei principali centri sacrali antichi e di grandissima importanza come questo.
L’altro insigne monumento albano, Alba Longa, che conserva una delle leggende più famose al mondo, è stato inutilmente cercato per secoli ovunque, soprattutto attorno al Lago Albano, a causa di quelle che vennero erroneamente ritenute incerte e vaghe indicazioni delle fonti antiche sulla sua esatta ubicazione. Tito Livio ubica Alba Longa alle pendici del Monte Albano, quindi in località Palazzolo, sul bordo del lago Albano su un’area pianeggiante, ma poi pare contraddirsi, quando aggiunge che essa si trovava lungo la dorsale del monte. Dionigi di Alicarnasso sembra voler smentire Livio, quando, al contrario, la descrive in posizione dominante, con difese naturali possenti tanto da essere considerate vere e proprie mura.
Queste apparenti contraddizioni, non solo hanno finito per delegittimare le rispettive indicazioni sull’ubicazione di Alba Longa, ma hanno alimentato il sospetto che essi, così come i loro contemporanei, avessero cognizioni assai vaghe sull’ubicazione di Alba Longa, Per queste ragioni Alba Longa è stata cercata ovunque in modo del tutto arbitrario, soprattutto attorno al Lago Albano, non sempre dalle parti del Monte Albano. La ricerca dei resti di Alba Longa, distrutta dal re Tullo Ostilio, intesa come città fortificata, con templi, edifici pubblici, strade, ecc., ha affiancato nel corso dei secoli i nomi più prestigiosi di studiosi italiani e stranieri. A costoro si opponevano gli scettici, anch’essi molto numerosi e questa contrapposizione ha generato una produzione letteraria enorme. Nell’insieme, vanno però distinti gli studi più antichi da quelli recenti che hanno avuto a disposizione una considerevole mole di dati nuovi e che hanno soprattutto potuto contare su una solida base scientifica in campo pre protostorico.
(Sulla devastazione del Monte Albano, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2021/05/28/la-grande-vergogna-dei-castelli-romani/)
La protostoria dei Colli Albani
Presso Castel Gandolfo, tra il 1816/1817, durante la costruzione di una strada. vennero alla luce numerose tombe, mai viste prima. Le ossa dei defunti, una volta incinerati, venivano deposte in un’urna fittile a forma di capanna accanto ad altri oggetti di corredo, tutti collocati entro un grosso contenitore (dolio). Sia nei corredi presenti nelle tombe femminili che maschili si rinvennero inoltre oggetti miniaturizzati. La rozzezza di quei vasi non lasciò dubbi: in quel luogo erano sepolti gli abitanti di Alba Longa. Dalla seconda metà dell’ottocento si iniziano ad impiantare i vigneti nella regione sud occidentale dei Colli Albani. Lo scassato agisce in grande profondità e vennero alla luce numerose necropoli protostoriche: se ne contarono 56 tra necropoli e tombe isolate negli anni ’60 del secolo scorso. Nella sua monumentale opera, lo studioso svedese Pär Göran Gierow ha raccolto quei corredi, quasi tutti rimescolati e perciò pressoché inservibili alla ricerca (P. G. GIEROW, The Iron Age Culture of Latium, 2.1. Excavations and finds. The Alban Hills, Lund 1964).
Ciò nonostante, risale al 1974 il coraggioso tentativo di Giovanni Colonna di inquadrare la cultura laziale dell’età del ferro sulla base di cronologie che altri stavano proponendo in quegli anni (G. COLONNA, Preistoria e protostoria di Roma e Lazio, in Popoli e Civiltà dell’Italia antica, II, 1974, pp. 273-346). Anch’egli però, partì dal presupposto errato secondo il quale, in tutto il Lazio protostorico, tutte le tombe fossero, senza eccezione, ad incinerazione e collocate nel dolio entro un pozzetto. In questo modo si perdeva l’occasione di distinguere, come poi avvenne, i vari ruoli dei defunti all’interno delle rispettive comunità e quindi di risalire alla struttura sociale degli abitati latini protostorici.
Iniziando dal confronto tra i sepolcreti albani e quelli laziali, Colonna sottolineò la straordinaria fioritura demografica e l’intensa occupazione dei Colli Albani nella parte occidentale della regione, esaltando la funzione di guida culturale dei Colli Albani nei confronti del Lazio che derivava dall’ideologia funebre del tutto esclusiva e completa che veniva emanata nel Lazio ed anche nelle regioni limitrofe. Con i dati di allora, solo qui, infatti, si trovavano associati l’urna a capanna, gli idoletti, i cosiddetti candelabri, le armi ed altri oggetti miniaturistici ed altri oggetti in oro e ambra, pressoché assenti nel resto del Lazio. Egli giunse pertanto ad una prima conclusione, e cioè che la cultura dell’età del ferro nel Lazio ebbe la sua culla sui Colli Albani, collegando senza mezzi termini l’egemonia culturale albana alla indiscussa supremazia di Alba Longa nel Lazio (che egli ubica a Castel Gandolfo) intesa come città madre di tutti i popoli latini, in perfetto accordo con quanto insistentemente ribadito dalla tradizione antica.
Ma poi, trattando della seriazione cronologica dei materiali restituiti dai sepolcreti albani, effettuata sulla tipologia del vasellame recuperato, egli assegnò questa fase egemonica al momento più antico dell’età del ferro (periodi I -IIA – metà IX sec. a.C.) giungendo alla seconda conclusione, a dir poco preoccupante, fondata sull’improvvisa assenza nei corredi funebri di materiali pertinenti alla fase immediatamente successiva (II-B – seconda metà del IX sec a.C.).
In base a questa assenza, senza mezzi termini, Colonna riconobbe in questa cesura i prodromi del collasso culturale dei Colli Albani, ipotizzando apertamente lo spopolamento generalizzato e l’abbandono dell’intera regione da parte delle genti albane, datando nettamente la fine del loro ruolo di guida culturale della regione alla seconda metà del IX sec. a.C. Tutto ciò è avvenuto – sempre secondo Colonna – in perfetto accordo con i dati tramandati dalle fonti antiche, secondo i quali, alla distruzione di Alba Longa, seguì la traduzione in Roma di tutti i suoi abitanti assieme alle famiglie aristocratiche più importanti (Cleli, Curiazi, Gegani, Giuli, Metili, Quintili e Servili).
Il collasso culturale albano venne inoltre collegato da Colonna al conseguente e immediato sviluppo di Roma e dei centri latini di pianura dovuto ai nuovi influssi provenienti dalla Campania, giustificando lo spopolamento delle genti montane dei Colli Albani evidentemente estranee alle nuove dinamiche culturali che avevano prodotto la fioritura dei centri di pianura.
Riassumendo, le vicende delle necropoli albane vennero usate strumentalmente per confermare i due momenti che la tradizione antica assegnava ad Alba Longa: la sua egemonia nel Lazio e poi la successiva distruzione. In seguito, queste teorie vennero purtroppo accolte favorevolmente anche da altri studiosi.
In questo contesto, solo pochi studiosi hanno dissentito dalla posizione scientifica che si andava diffondendo. Infatti, nel 1976, appena due anni dopo la pubblicazione della sintesi di Colonna, le sue teorie sullo spopolamento dei Colli Albani furono duramente contestate da Massimo Pallottino, il quale giudicò “impensabile” un vuoto insediativo tra la distruzione di Alba e la nascita, appena un secolo dopo, di ben cinque importanti città albane: Tuscolo Ariccia, Lanuvio, Velletri e Labico (M. PALLOTTINO, Inquadramento storico, in Catalogo della mostra Civiltà del Lazio primitivo, 1976, pp. 37-55).
In seguito, accanto a queste ovvie considerazioni, fu obiettato che il presunto collasso culturale dei Colli Albani veniva datato da Colonna alla metà del IX secolo a.C., quando, al contrario, la tradizione antica assegnava la distruzione di Alba Longa due secoli dopo, alla prima metà del VII secolo a.C. (Dialoghi di Archeologia, La formazione della città nel Lazio, seminario tenuto a Roma, 24-26 giugno 1977, 2, Discussione, p. 193 ss.). Questo divario cronologico aumentò addirittura fino a tre secoli in seguito alla successiva revisione cronologica del 2003 che innalzava di un secolo l’inizio dell’età del ferro nel Lazio (F. ARIETTI, discussione e interventi, p. 631 ss,, in: Oriente e Occidente, metodi e discipline a confronto – riflessioni sulla cronologia dell’età del ferro in Italia, Atti dell’Incontro di Studio, Roma, 30-31 ottobre 2003, a cura di G. Bartoloni e F. Delpino, Pisa- Roma 2005).
Concludendo, la difesa ad oltranza della validità delle fonti antiche sulle vicende di Alba Longa fatta da Colonna utilizzando la città dei morti – dal momento che la città dei vivi non si trovava – generò due paradossi. Il primo fu quello di stroncare sul nascere la civiltà albana; il secondo consiste nel fatto che proprio la millenaria civiltà albana avrebbe invece confermato, in ben altra forma naturalmente, la natura delle fonti antiche, la cui validità Colonna voleva difendere a spada tratta per opporsi alla posizione degli scettici.
La “rivoluzione scientifica” a partire dagli anni ’70 del secolo scorso
In quegli anni iniziava la grande rivoluzione scientifica. Finalmente ora gli archeologi scendevano in campo e uno dopo l’altro venivano alla luce i principali centri latini del Lazio antico menzionati dalle fonti antiche. Dalla necropoli di Gabi, che restituì circa 600 tombe, arrivò la prima sorpresa: il rituale dell’incinerazione era esclusivamente riservato a pochi individui (in questo caso a maschi, adulti) che avevano ricoperto ruoli importanti nell’ambito della comunità (politico, religioso).
Inoltre – come sui Colli Albani – a Gabi si rinvennero ugualmente associati, l’urna a capanna, la statuina fittile, le armi e i vasi in miniatura, assieme a tutto il repertorio vascolare ben noto sui Colli Albani, invalidando quindi l’ipotesi di Colonna circa il rigorismo ideologico funebre specifico ed esclusivo dell’area albana, da lui posta alla base della sua presunta egemonia culturale sul resto del Lazio.
Gli scavi di Castel di Decima (forse Politorium) e della Laurentina (forse Tellene) hanno restituito materiali delle fasi successive, così come Crustumerium, Fidene, Collazia e la stessa Roma nella quale sono documentate invece tutte le fasi dell’età del Ferro. Altre testimonianze sparse, relative a vari momenti dell’età del ferro vennero effettuate in varie località. Questo primo gruppo di scoperte furono effettuate dalla sola Soprintendenza archeologica di Roma. Nel giro di vent’anni, nei magazzini della soprintendenza vennero portati circa 20.000 oggetti.
Negli stessi anni si scavarono altri centri latini protostorici importanti: Lavinio, Ficana, Satricum, Ardea, mentre vennero ripresi gli studi sugli straordinari materiali delle necropoli di Preneste e Tivoli. Si è così compreso che, per tutta l’età del ferro, gli abitati protostorici latini erano senza eccezione formati ancora da capanne, ed erano posti su ampi pianori sopraelevati, difesi da fortificazioni ad aggere. Inoltre, mentre i sepolcreti della prima età del ferro (fine XI – IX se. a.C.) erano sempre posti lungo le strade e nelle immediate vicinanze dell’abitato, nella seconda fase, tra VIII e VII sec. a.C. quando nascono i confini dei vari centri, i sepolcreti si trovano invece in zone spesso assai distanti dall’abitato, comunque sempre accanto ai tracciati stradali.
In quegli anni sono iniziati gli studi degli abitati, stavolta su basi scientifiche certe, relativi alla struttura sociale, all’economia, demografia, con grande attenzione anche al paesaggio. Inoltre, gli straordinari e ricchissimi corredi funebri delle cosiddette tombe principesche della seconda età del ferro hanno attestato, accanto all’affermazione delle aristocrazie nel Lazio, la circolazione di beni di prestigio provenienti soprattutto da varie regioni del vicino oriente, che ha postulato l’ipotesi della produzione di questi oggetti anche nel Lazio, attraverso la presenza di artigiani, anche orientali, attivi in botteghe specializzate nella fabbricazione di oreficerie, oggetti in bronzo e ferro, carri, ecc.
Nell’insieme, le necropoli latine hanno mostrato una grande omogeneità culturale all’interno del Lazio per quanto riguarda tutte le fasi dell’età del ferro, oltre ad una vitalità sorprendente e del tutto inaspettata. Nel 1976 gli straordinari corredi funebri laziali vennero presentati al grande pubblico in una mostra che ebbe una notevole risonanza e un successo che andò ben oltre le aspettative degli organizzatori. In particolare, vennero mostrate per la prima volta al pubblico le cosiddette tombe principesche. Com’è noto infatti, a partire dagli inizi dell’VIII sec. a.C., soprattutto dalla seconda metà, si assiste alla progressiva affermazione delle aristocrazie laziali, che si manifesta soprattutto con l’ostentazione della loro ricchezza attraverso il lusso funerario. Lo sfoggio delle insegne del potere politico-religioso ora avviene attraverso l’esaltazione della genealogia e l’elevazione dei rispettivi capi al rango di “re“ all’interno della propria cerchia sociale, che deriva soprattutto dal ruolo dei Fenici nella diffusione in occidente dei modelli orientali e del conseguente stile di vita improntato alla tryphé. Nelle tombe laziali più prestigiose compaiono i troni (in bronzo o legno) i suppedanei e addirittura i flabelli, mentre accanto a loro, si depongono tutte le insegne del potere gentilizio e gli oggetti più preziosi importati dal vicino oriente.
A questo rivoluzionario ed epocale risveglio scientifico nei confronti dei maggiori centri del Lazio antico, si contrappose il totale silenzio e disinteresse scientifico per i Colli Albani, nella cui immensa regione non venne condotto alcuno scavo archeologico. Nel corso degli innumerevoli dibattiti in tema di archeologia laziale, la protostoria albana divenne pertanto del tutto marginale. Si può dire che, da allora, l’intera regione albana venne tristemente percepita dalla maggior parte degli studiosi come un immenso spazio pressoché vuoto, dove riecheggia ancora la vetusta storia dell’egemonia di Alba Longa nel Lazio, con la sua lunga dinastia di re culminata con la nascita dei gemelli fondatori, terminata con la sua totale distruzione voluta dal re Tutto Ostilio e conseguente traduzione a Roma dei suoi abitanti.
Riassumendo, con la grande “rivoluzione degli anni ’70”, un dato inoppugnabile ed un punto fermo a livello scientifico scaturito da quelle ricerche riguarda il fatto che se Alba Longa fosse realmente esistita, sarebbe stato solo un villaggio di capanne.
Alba Longa a Castel Gandolfo
Concludendo con Castel Gandolfo, va osservato che il sito non si presta affatto ad essere considerato un abitato protostorico. Innanzitutto perché è in discesa e pertanto indifendibile, inoltre il paese è largo appena 50 metri e lungo 250 metri, sviluppando nell’insieme appena un ettaro o poco più (contro i 160 ha di Roma, i 50 ha di Ardea e 40 ha di Gabi solo per fare alcuni esempi). La necropoli, considerata per tanto tempo il sepolcreto di Alba Longa, dista un km. dall’abitato ed è posta a circa 150 metri più in basso da esso; in altre parole, si trova a circa un’ora di cammino da Castel Gandolfo, cosa inimmaginabile in un periodo nel quale le necropoli laziali risalenti all’XI-X secolo a.C., si trovano tutte, indistintamente, nelle immediate vicinanze dell’abitato, lungo percorsi stradali ((F. ARIETTI, Gli Albani e il loro territorio nell’VIII e VII sec. a.C., in Alba Longa: Mito, Storia, Archeologia, Atti dell’Incontro di studio, Roma-Albano Laziale 27-29 gennaio 1994 (Studi pubblicati dall’Istituto Italiano per la Storia Antica, fasc. LX), a cura di Anna Pasqualini, Roma 1996, p. 29 ss.; Idem., Alba e gli Albani, in Il Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra preistoria ed età moderna, a cura di L. Drago Troccoli, Roma 2009 p.163 ss.).
Del resto, nessuno tra quanti hanno ubicato Alba Longa a Castel Gandolfo, ha mai studiato direttamente e pubblicato questo luogo. Quasi tutti hanno semplicemente rimandato in modo generico alle conclusioni di Giuseppe Lugli, il quale riconobbe in Castel Gandolfo l’Arx Albana, menzionata da Tacito nell’Agricola, l’elogio funebre dedicato a Giulio Agricola suo suocero, probabilmente fatto uccidere da Domiziano, il quale possiede una grandiosa villa da quelle parti. Eppure, in questo minuscolo e delizioso paese, molti, sono riusciti ad immaginare la rocca di Alba Longa, la grande metropoli delle origini, governata da una lunga dinastia di re, cinta da mura, con edifici pubblici, templi e strade, che avrebbe fondato tutti i maggiori centri latini di pianura e che avrebbe partorito una delle leggende più famose al mondo.
Il Convegno su Alba Longa
Il convegno su Alba Longa del 1994, curato da Anna Pasqualini (Alba Longa: Mito, Storia, Archeologia, cit.), conclude storicamente il periodo della grande rivoluzione protostorica e finalmente richiama l’attenzione degli studiosi su un tema del tutto ignorato nei decenni passati, quello di Alba Longa. Questo convegno ha avuto il merito di riunire vari specialisti che hanno contribuito a comporre, soprattutto sul piano storico, un quadro organico e finalmente esaustivo sulla genesi della leggenda di Alba Longa così come appare nella celebre vulgata. Questo momento segna scientificamente la fine di Alba Longa intesa come città realmente esistita ed apre nel contempo un grande spazio d’indagine attorno alla nascita del mito. E della leggenda di Alba Longa Alexandre Grandazzi tratta ampiamente nei due volumi pubblicati nel 2008 (A. GRANDAZZI, Alba Longa. Histoire d’une légende, Rome, École française de Rome, 2008, 2 vol.).
Ma, a questo punto, il vero problema, apparentemente irresolubile, fino a ieri era ancora questo: per risolvere il mistero di Alba Longa sarebbero occorsi due veri e propri miracoli. Il primo riguarda la sua ubicazione: come si fa a trovare un luogo leggendario, un “non luogo”? Ma anche se ciò fosse possibile, sarebbe solo una scatola vuota poiché non racconterebbe nulla, così come tutte le decine di Alba Longa finora trovate ovunque; il secondo miracolo, ancora apparentemente più impossibile del primo a realizzarsi, dovrebbe raccontare la formazione e la nascita della leggenda di Alba Longa, a prescindere da quello che già la critica storica ha già concretamente stabilito sulla formazione della (tarda) vulgata attraverso la saga lavinate e la fondazione di Alba Longa.
PARTE
II
Il territorio degli Albani
Questo territorio è particolarissimo e fondamentale per comprendere il mondo albano. Tra le due cinte crateriche concentriche si estende una valle anulare che si sviluppa ininterrottamente in modo circolare per una lunghezza di circa 22 km, quasi interamente conservata. I microclimi sono invece assai diversi: la zona orientale del Vivaro risulta essere assai umida e nebbiosa, adatta al pascolo (ancora oggi non si presenta antropizzata); al contrario, lungo quella occidentale e meridionale si concentrano soprattutto le coltivazioni dei vigneti.
Per l’età pre-protostorica, la prima osservazione riguarda l’omogeneità territoriale: la valle anulare interna si può percorrere ininterrottamente per tutta la sua estensione circolare senza trovare ostacoli, e ciò rende l’idea di un territorio complessivamente aperto, privo di discontinuità morfologiche, dal quale è possibile raggiungere ogni recesso collinare adiacente. In altre parole, qualunque sito che si prestasse all’insediamento era raggiungibile dall’interno e ciò costituiva la particolarità del territorio albano, totalmente diverso dai centri latini di pianura: infatti, ogni abitato poteva disporre di ampi spazi attorno a sé e godere di relativa autonomia territoriale e talvolta di difese naturali proprie sulle alture, ma, nel contempo, non poteva sottrarsi alla concatenazione insediativa ed ai percorsi stradali che obbligavano ad attingere alle medesime risorse economiche distribuite negli spazi comunitari. L’attività della pastorizia, ad esempio, che richiede ampi spazi adibiti a pascolo deve aver creato non pochi problemi a livello di convivenza, soprattutto a partire dall’età del bronzo.
Il Monte Albano
L’esatta ubicazione e la morfologia del Monte Albano non sono mai state oggetto di studio; ed è proprio questa omissione ad aver creato molta confusione a livello scientifico, dal momento che il Mons Albanus è stato spesso menzionato nell’antichità, in particolare per ubicare ad esempio luoghi come Alba Longa o il Capo d’Acqua Ferentina. Dal punto di vista geografico e sotto l’aspetto strettamente fisico, è importante tener presente che quando si parla di Monte Albano ci si trova al cospetto di un cono di scorie, quindi di una modesta altura che poggia sulla cinta craterica (il Recinto delle Faete) e non di fronte ad un monte isolato.
(Sul territorio albano e quello romano, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/la-citta-albana/)
(Per la necropoli di Villa Cavalletti a Grottaferrata, vedi http://www.osservatoriocollialbani.it/2018/12/26/necropoli-protostoriche-albane-villa-cavalletti-grottaferrata/)
(Sulla Necropoli di S. Palomba presso Ariccia, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2017/06/03/aaa/)
(Per la recente scoperta di alcune necropoli e rispettivi abitati protostorici presso la vetta del Monte Albano, vedi:http://www.osservatoriocollialbani.it/2019/11/06/monte-cavo-scoperte-tre-necropoli-e-altrettanti-abitati-preromani/)
PARTE
III
Il Culto dei Lari nella prima età del ferro (XI-IX sec. a.C.)
Il millenario culto domestico degli antenati venne stroncato dall’editto dell’imperatore Teodosio del 398 e nelle case i larari vennero vietati assieme al culto del focolare. I due giovinetti festanti del larario pompeiano rinvenuto nella Casa dei Vettii, li ritroviamo, nella medesima posizione simmetrica, sulla porta di un’urna a capanna di Castel Gandolfo, più antica di oltre mille anni (P. G. GIEROW, cit., p.313 fig 190). Da tempi immemorabili, la capanna era posta al centro dell’universo, secondo una visione cosmocentrica che suddivideva lo spazio circostante in cerchi concentrici, occupati prima dall’orto, poi dalle strade che portano alle fonti, ai campi, ai boschi e infine alle selve.
Questo mondo, con i suoi abitanti, era protetto dai Lari, gli antenati, il cui nome deriva dagli alari del focolare, posto al centro della capanna, che divenne l’epicentro sacrale di quello spazio. La fiamma, sempre accesa, si trasformò nella prima divinità domestica, e il ruolo delle bambine e fanciulle che l’accudivano, acquistò con il tempo la celebre dimensione sacerdotale delle vergini vestali. Lo sviluppo della civiltà albana di età protostorica segna il punto di arrivo della millenaria esperienza culturale precedente, della quale le immense e impenetrabili foreste raccontavano la storia. La magia di quel mondo selvaggio rimase incontaminata per millenni, fino a quando i primi gruppi umani furono attratti dalla sacralità di quella natura. Quelle selve misteriose divennero col tempo le dimore divine di entità sfuggenti, percepite appena come magiche presenze.
Primitivi padroni delle sterminate e impenetrabili selve, il picchio e il lupo divennero le antichissime divinità primordiali di quei luoghi. Nella millenaria evoluzione che trasformò questi due animali in Pico e Fauno – i primitivi eroi civilizzatori di Alba e del mondo latino – si sono cristallizzati i complessi processi religiosi che li hanno tramutati e descritti come fondatori e re, principali protagonisti primordiali delle leggende più antiche. Il ricordo di quelle selve primordiali in cui vissero gli antenati albani venne perpetuato nella leggendaria dinastia dei re di Alba, i Silvii, che regnarono per molte generazioni sul loro monte sacro. Tra essi, Rea Silvia divenne la prima vestale della storia.
Nella prima età del ferro, il mondo dei lari, gli spiriti buoni come li definisce sant’Agostino (citando Apuleio), si può forse riconoscere in alcune rappresentazioni presenti nei corredi funebri albani attraverso coppie di personaggi, come quelli che appaiono sulla porta dell’urna a capanna di Castel Gandolfo, oppure resi in bronzo, rinvenuti accanto ai due animali aggiogati nella tomba 6 di S. Palomba presso Ariccia. Questi ultimi vanno intesi come aratori, e, probabilmente, come tali, protettori dei campi, allo stesso modo delle celebri composizioni campane più recenti, che più esplicitamente, esprimono la sacralità della rappresentazione attraverso l’individuo con il vomere reso con entrambi i sessi che incarna i due momenti della semina e del raccolto.
A partire dalla fine dell’XI secolo a.C., l’organizzazione sociale albana viene riflessa nei corredi funebri ad incinerazione riservati ai membri che hanno svolto ruoli importanti nelle rispettive comunità. Accanto alle tre tombe femminili rinvenute a Rocca di Papa, Grottaferrata e Castel Gandolfo (P. G. GIEROW, cit., p. 278, fig. 169; p. 87 fig.43; p.313, fig. 190), giustamente riconosciute in passato come pertinenti alle vestali, nelle tombe maschili, il ruolo di capi politici e religiosi è rappresentato, oltre che dalle armi, dai i doppi scudi, ed eccezionalmente, rispetto alle altre necropoli laziali, anche dai carri. Benché si manifesti in forma embrionale, la dimensione sacerdotale dei futuri sacerdozi dei Sali e delle Vestali, è chiaramente documentata archeologicamente nel mondo Albano già a partire dal X sec. a.C. Sotto il profilo cultuale, di grande importanza si rivelano le scoperte di abitati e relative tombe, degli inizi dell’età del ferro, recentemente rinvenuti tutt’attorno alla vetta del Monte Albano, che documentano la presenza precoce di gruppi attivi presso l’area sacra.
Il Culto dei Lari nella seconda età del ferro (VII-VII sec. a.C.)
A partire dagli inizi dell’VIII sec. a.C., in particolare dalla seconda metà, si assiste alla progressiva affermazione delle aristocrazie albane, che si manifesta soprattutto con l’ostentazione della loro ricchezza attraverso il lusso funerario.
Le genti albane fondano ora il loro potere su una solida struttura sociale gerarchizzata, rivendicando la proprietà della terra ed il diritto della sua trasmissione ereditaria (heredium), mentre la crescita demografica, probabilmente dovuta all’aggregazione di gruppi subordinati (clientes), garantisce un notevole sviluppo economico e un conseguente surplus di ricchezza. Il culto degli antenati nell’ambito dell’istituto della clientela, assume ora un’importanza fondamentale, essendo disciplinato in modo da garantire giuridicamente la proprietà della terra al nuovo ceto dominante.
Ciò avviene alla vigilia della nascita di ben cinque città, postulata dalla presenza di numerose curie gentilizie dislocate su tutta l’area albana. Nonostante la pressoché totale assenza di indagini archeologiche, il territorio albano ha restituito in vari punti ben sei tombe di altissimo livello, rinvenute casualmente e scavate senza alcun controllo.
Dopo mille anni di convivenza, documentata archeologicamente dalla media età del bronzo per tutta l’età del ferro, l’evoluzione della struttura sociale tende ora ad essere omologata ovunque sulla base di modelli adatti a favorire gli scambi di varia natura ed ogni altra forma di contatto tra i vari gruppi aristocratici; quasi certamente, dovette prevalere, da un lato, la necessità di uniformare i sistemi matrimoniali e le modalità di suddivisione del corpo sociale in classi di età, così come le scansioni calendariali collegate alle comuni attività produttive, ecc.; dall’altro, anche le attività religiose, così come le feste, ebbero la necessità di corrispondere alle nuove esigenze collettive.
Le fonti antiche attribuiscono l’origine delle ferie Latine ai prisci Latini oppure a Tarquinio il Superbo (ma sappiamo che spesso egli viene scambiato erroneamente con Tarquinio Prisco). Servio, spiegando che Priscos Latinos ita dicti sunt qui tenuerunt loca, ubi Alba est condita, ha identificato con assoluta precisione i prisci Latini con gli Albani. Dunque, autorevoli fonti antiche hanno tramandato quello che l’imponente documentazione archeologica e un’attenta analisi storica hanno accertato con inoppugnabili argomentazioni: ora sappiamo con certezza che le famose ferie nascono e si strutturano progressivamente tra gli albani, in età protostorica.
A questo punto è necessario introdurre un correttivo fondamentale: le feste di cui si parla non sono affatto “Latinae”, ma esclusivamente “Albanae”, e tutto lascia pensare che esse abbiano avuto lo scopo principale di sancire – attraverso istituzioni religiose stabili – un vincolo comunitario inteso come atto finale di un lunghissimo processo d’integrazione.
Sulla vetta del Monte Albano, le origini di questi culti sono garantite dal tipo delle offerte, legate al mondo della pastorizia (agnelli, latte, formaggio e focacce di miele), quindi da consuetudini precedenti all’introduzione del vino nel corso dell’VIII sec. a.C., bevanda tipica di Giove. Dunque, la comunione religiosa tra i numerosi gruppi tribali albani prima e le curie gentilizie poi, si rese necessaria per rinsaldare, anno per anno, il principio di comunità etnica; questo legittima l’ipotesi che essi, oltre agli dei, venerassero anche antenati comuni. Pertanto, probabilmente già dall’età protostorica, il Monte Albano e Alba Longa rappresentarono per gli Albani due spazi cultuali ben distinti, rispettivamente riservati agli dei e al culto degli antenati.
(Sulla tomba “Principesca” del Vivaro di Rocca di Papa, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2019/12/13/la-tomba-della-principessa-del-vivaro-di-rocca-di-papa-di-3000-anni-fa/)
PARTE
IV
Le strade del Monte Albano
Il tracciato primordiale che costeggia i due laghi ricalcato dalla moderna via dei Laghi fu una delle prime vie di penetrazione all’interno del vulcano Laziale che attraversò le millenarie foreste impenetrabili. Questa strada risulta fondamentale per comprendere l’assetto viario delle vie che risalgono il Monte Albano. Essa percorre il passaggio obbligato tra le pendici esterne della cinta craterica e il bordo del Lago di Nemi. Questo percorso risulta particolarmente frequentato in età protostorica come dimostrano le numerose tombe che lo fiancheggiano.
La strada arcaica del Monte Albano, il capo d’Acqua Ferentina e le ferie Latine
Per secoli, ogni anno, i popoli latini salivano sul Monte Albano per le loro attività religiose. Nessuno finora si era preoccupato della strada che essi percorrevano, prima che venisse costruita la via lastricata agli inizi del secondo secolo a.C. L’identificazione della via arcaica, da cui è iniziato il mio studio, assume una straordinaria importanza per molte ragioni. Il percorso delle due strade sovrapposte era lo stesso a partire dalla vetta almeno fino alla via dei Laghi. Da qui la via lastricata proseguiva fino ad Ariccia per allacciarsi all’Appia Antica. La via arcaica invece raggiungeva la fonte perenne di Fontan Tempesta, appena superata la Via dei Laghi. Questa fonte fu frequentata già dall’età del bronzo e nelle epoche successive.
Presso la fonte si apre la grande area pianeggiante delle Piagge. La scoperta di quest’area è assai importante e fondamentale, perché ora possiamo distinguere e separare i due luoghi delle ferie Latine: le ferie, cioè le feste, si tenevano alle Piagge; le Latine, cioè le celebrazioni religiose, sulla vetta del Monte Albano.
In particolare alle Piagge, ogni anno, si radunavano e sostavano le delegazioni dei popoli latini nei tre giorni delle ferie Latine. Costoro venivano da ogni parte del Lazio e viaggiavano in drappelli costituiti da numerosi carri, cavalli, scorte armate a protezione dei rispettivi capi o delegati che presiedevano alle celebrazioni sulla vetta. Al seguito viaggiavano anche gli atleti che partecipavano ai ludi, Plinio menziona una cinquantina di populi che in età repubblicana partecipavano alle ferie Latine (ma erano di più, ad es. erano invitati anche i volsci di Alba Fucens); Dionigi ne elenca circa 47. Pertanto, centinaia tra uomini, cavalli e carri dovevano sostare alcuni giorni in uno spazio adeguato che doveva prevedere aree specifiche per il bivacco, per i ludi, ecc., ma anche la presenza fondamentale di una fonte d’acqua perenne come quella di Fontan Tempesta.
Per concludere sul primitivo percorso della via arcaica ed a quello della via lastricata che vi si sovrappone, risulta fondamentale la carta di Pietro Rosa redatta tra 1850 – 1870, nella quale egli poteva ancora vedere il tratto oggi non più visibile di strada arcaica che dalla fonte perenne saliva unendosi alla via lastricata ad essa sovrapposta. Sappiamo che le strade arcaiche consentivano il transito di un solo carro alla volta. Se due carri provenivano da direzioni opposte, uno dei due doveva sostare nelle piazzuole distribuite lungo il percorso. Ciò significa che solo le autorità salivano sulla vetta per presiedere alla cerimonia della comunione.
Fin dalle origini e per secoli, nella spianata delle Piagge, si tenevano manifestazioni di ogni genere, non solo quelle legate alle ferie Latine. Ad esempio, i ludi in onore di Giove Laziale (le olimpiadi latine). La loro importanza e sacralità viene probabilmente riflessa dallo straordinario corredo funebre dall’atleta di Lanuvio che si data agli inizi del quinto secolo a.C. Sappiamo che in questo periodo i corredi funebri erano tassativamente vietati in tutti i centri latini (da cent’anni) dalle leggi contro il lusso funerario. Il motivo di questa vistosa eccezione va sicuramente ricercato nel fatto che questo atleta ha partecipato ai giochi sacri in onore di Giove risultando vincitore rappresentando un vanto per la città di Lanuvio che ha tributato gli onori funebri ad un membro della sua aristocrazia. (Lanuvio dista appena 6 km dal pianoro delle Piagge). La presenza nel corredo del disco da lancio documenta il fatto che egli eccelleva in questa specialità, ma forse anche in altre due: nella lotta libera (presenza dello strigile ed il sacchetto della sabbia) e, come sembrerebbe dalle decorazioni del disco incise su entrambe le facce, egli si cimentava anche nelle gare di abilità acrobatiche a cavallo. Quindi egli gareggiava anche come desultor.
Per quanto riguarda i trionfi, probabilmente essi avvenivano già in età arcaica e molte cerimonie (si pensi alla questione dell’esecuzione di un condannato a morte quando le ferie furono trasferite a Roma, conservando forse, a livello rituale, anche questo feroce atto di bere il sangue dei capi nemici; per questo v.: M. MALAVOLTA, I Ludi delle feriae Latinae a Roma, in Alba Longa, cit., pp. 255-273). Altrimenti non si potrebbe spiegare l’incomprensibile serie di trionfi minori che all’improvviso, in età medio repubblicana, si tennero sul Monte Albano, evidentemente legittimati dal fatto che esistevano precedenti più antichi.
Per concludere, un’ultima importante riflessione s’impone riguardo alla contemporanea presenza nell’area delle Piagge dei principali capi latini durante il loro soggiorno annuale durante le ferie Latine; questa era una straordinaria occasione anche per incontri ad alto livello. Se consideriamo che le stesse persone rappresentavano i rispettivi populi anche nel corso delle adunanze politiche della lega latina che avvenivano saltuariamente presso la celebre Fonte Ferentina, è quasi certo che il famoso capo d’acqua Ferentina debba coincidere con la moderna fonte di Fontan Tempesta. Se abbiamo colto nel vero, come tutto lascia credere, la moderna spianata delle Piagge dovrebbe coincidere con il Ferentino di Dionisio e anche di Livio. Quest’ultimo infatti, rispetto al nome dell’area in cui si radunavano i Latini, fornisce indicazioni assai vaghe e diverse tra loro: Capo d’Acqua Ferentina, lucus Ferentinae, ma anche Capo Ferentino. Infatti, citando gli eventi del 489 a.C. nei quali i Volsci tornano nei loro territori perché cacciati da Roma, egli specifica che Atto Tullio, il capo dei Volsci, arringa la folla “radunata in un campo sotto la via”. La strada è sicuramente il tracciato arcaico che coincide con la soprastante via dei Laghi che porta alla vicina Velletri, appunto in territorio volsco. Inoltre, il capo d’acqua Ferentina è posto da Festo alle pendici del Monte Albano. E forse, con le dovute cautele, il nome Ferentina potrebbe derivare da Feria Latina, fin dall’inizio, quando le feste duravano solo un giorno.
Infine, va considerato che i raduni della lega latina furono fatti in luoghi diversi. Quelli avvenuti presso la fonte Ferentina furono probabilmente i più antichi. Dopo i fatti di Turno Erdonio (fine VI sec. a.C.) l’area delle Piagge (il Ferentino) venne abbandonata a favore del santuario di Diana Aricina, posto nelle immediate vicinanze (come narrano le fonti antiche a proposito di Egerio Bebio). Ma anche questo luogo dovette essere presto abbandonato perché strategicamente insicuro a causa della pericolosa vicinanza con Velletri, città caduta in mano ai Volsci. Di altri luoghi per le adunate abbiamo notizie da Plinio (un Dianium è ubicato nel fondo di Passieno Crispo presso Frascati), oppure sono stati ipotizzati da vari studiosi.
La via lastricata
Costruita probabilmente nei 174 a.C., si stacca dalla Via Appia presso Ariccia e il suo percorso, fino alla vetta del Monte Albano, misura 7 km, dei quali 4, in leggera salita, fino alle pendici della cinta craterica, mentre i restanti tre dovevano affrontare un percorso in forte pendenza. Essa si sovrappone, ma solo nel tratto finale, al tracciato arcaico. Salendo, la strada oltrepassa la brevissima sella che separa il promontorio di Prato Fabio dalle pendici del Monte Albano. Questa separazione è materialmente accentuata da un grande muro lungo circa trenta metri costruito con grandi blocchi di tufo con facce bugnate posto sul lato della strada rivolto a monte.
I due tratti di strada, prima e dopo Prato Fabio, sono completamente diversi. Il primo, quello che sale dalla via dei Laghi fino al Prato Fabio per un tratto di circa 3 km., è largo 4m (13 piedi romani) e presenta le superfici dei basoli scalpellate.
Nel primo tratto, presso la via dei Laghi, si rinvengono tre falli scolpiti. Nei pressi, su un basolo al centro della strada appaiono anche due lettere di incerta attribuzione, sottolineate: CV. Del tutto improbabile che esse abbiano un carattere ufficiale e che alludano al curator viarum o ai curatores viarum; improbabile anche che siano numerali essendo sottolineati. Potrebbero essere letti come iniziali di clivus vetus, essendo iscritte su un basolo liscio. Questo primo tratto di strada è perfettamente conservato. Le crepidini alternano, regolarmente spaziati, singoli gomphi ad una serie di piccoli umbones.
Ma appena superato Prato Fabio, immediatamente dopo pochi metri, la strada si restringe da 4 m. a 2,70 m. (9 piedi romani). Da questo punto in poi, fino alla vetta che dista circa 900 metri, le superfici dei basoli sono lisce, al contrario di quelle del tratto precedente che sono scalpellate. Dopo pochi passi appare la prima lettera N scolpita sul basolo posto al centro della strada.
Il significato di molte lettere misteriose inscritte sui basoli, di norma la N e la V, è stato variamente interpretato gli studiosi si ogni età, ma senza alcun risultato concreto. Tre anni orsono, l’enigma è stato risolto osservando i grandi blocchi delle crepidini laterali della strada, detti gomphi: la presenza delle iscrizioni veniva sempre segnalata accoppiando quattro serie di gomphi che delimitavano la strada. In particolare, essi delimitavano 26 brevi tratti di lastricato restaurati in antico, lunghi di norma pochi metri ciascuno, segnalando con la lettera N il tratto novus con la V quello vetus; inoltre, le superfici dei basoli compresi nel tratto restaurato venivano sempre rigorosamente scalpellate. Eccezionalmente, anche alcuni gomphi accoppiati delle crepidini recavano le lettere inscritte, di solito la N, ma questa lettera compare solo sul blocco interno rivolto al tratto restaurato. Nei vari restauri effettuati nel corso dei secoli, la distribuzione delle lettere N e V venne resa in numerose formulazioni diverse; inoltre, in alcuni casi le lettere non compaiono, ma il restauro è sempre delimitato comunque dalla presenza delle quattro coppie di gomphi.
Come già accennato queste iscrizioni appaiono esclusivamente nell’ultimo tratto di strada lungo 900 metri che si restringe appena superato il promontorio di Prato Fabio. Si tratta di iscrizioni che non trovano confronti nell’imponente rete stradale romana. La scrupolosissima e metodica ripetizione delle medesime lettere in spazi assai ridotti, tradisce il profondo carattere religioso connesso alla sacralità del luogo: il bosco sacro di Giove, nel quale la strada ha fatto il suo ingresso.
(Sul Monte Albano, le strade, il bosco Sacro, sulla scoperta del luogo dove si tenevano le ferie, sulla Panoplia di Lanuvio e la fonte Ferentina, vedi:http://www.osservatoriocollialbani.it/2017/10/15/le-strade-del-monte-albano-rocca-di-papa/)
(Sulla Panoplia di Lanuvio, vedi:http://www.osservatoriocollialbani.it/2018/10/02/meraviglie-albane-da-conoscere-assolutamente-la-celebre-panoplia-di-lanuvio/
Il bosco Sacro di Giove Laziale
L’ esistenza del bosco Sacro di Giove Laziale ci viene tramandata in un noto passo di Tito Livio, e ben si accorda con la rilevante importanza del centro sacrale latino. Come tutti i luoghi sacri, il bosco era inviolabile e rigidamente protetto da ogni tipo di profanazione. L’ingresso era vietato a chiunque e veniva consentito solo nei giorni stabiliti per le cerimonie di culto. Il divieto, nelle forme più estreme, poteva prevedere anche la pena capitale. Per assicurare la protezione rituale vigevano numerose norme, a cominciare da quella più nota e diffusa che prevedeva il severissimo divieto di tagliare o manomettere alberi se non per usi sacrali. Accadeva poi che alberi o rami secchi cadessero da soli; ciò richiedeva ugualmente un sacrificio espiatorio. Un’altra norma comune a tutti i boschi sacri era quella che prevedeva sacrifici espiatori prima e dopo qualunque lavoro di manutenzione ordinaria, come ad esempio gli interventi che riguardavano le strutture degli edifici sacri e le strade del lucus. Il bosco sacro si estende per circa 80 ettari. Si può comprendere la sua grandiosità dal confronto con il celebre bosco sacro della Dea Dia, che secondo John Scheid misurava appena mezzo ettaro ed era raggiunto da una strada lunga forse cento metri che inizialmente si staccava dalla via Campana e successivamente da un diverticolo della Portuense (sulle dimensioni del bosco sacro calcolate da J. Scheid permangono comunque delle perplessità).
La recentissima scoperta del bosco sacro di Giove Laziale si rivela pertanto di straordinaria importanza poiché le sue delimitazioni sacrali coincidono perfettamente con la morfologia del Monte Albano, così come veniva intesa nell’antichità, la quale corrisponde a sua volta con la moderna definizione di Monte Cavo. Quindi, la configurazione sacra di tutto il Monte Albano, fino alle sue pendici, diventa di estrema importanza, poiché ora sappiamo che il maestoso promontorio di Prato Fabio era evidentemente estraneo al Monte Albano, sia a livello giuridico sacrale che dal punto di vista morfologico.
PARTE
V
La vetta del Monte Albano. Il convento
Un discorso a parte merita la distruzione sistematica del tessuto archeologico operato nel corso dei secoli, in particolare dai monaci, ad iniziare dalla costruzione del primo eremo del 1723 dai PP. Trinitari probabilmente eseguita con la distruzione di materiale antico. Le spoliazioni e distruzioni sistematiche continuarono in particolare tra il 1774 e il 1779 con l’ampliamento del convento e la ricostruzione della chiesa ad opera dei PP. Passionisti.
In quest’ultimo periodo, la cronaca annuale del convento elenca una serie di ritrovamenti – che riportiamo integralmente di seguito – tra cui spicca quello di una stipe votiva “…. Scavando le fondamenta per il nuovo braccio e della chiesa furono trovati ancora quantità di marmi, parte dei quali furono serviti per la chiesa…..si trovarono altresì diversi idoli di metallo della lunghezza di mezzo palmo (11 cm circa ndr) tutti con qualche attributo di Giove e per lo più fulminante i quali furono dati a diversi dilettanti e due furono regalati, cioè uno con l’ale e l’altro co’ fulmini nella destra, ai principi Doria D. Andrea e D. Giorgio il 9 ottobre 1779. Furono anche trovati dei rottami di statuette, fantocci si di uomini che di donne e di bestie, tutti però di creta ma non di buona mano, ed altre cornici e fiorami; ma il più pregevole fu un dito di bronzo più che gigantesco, un piedestallo con al di sopra ambedue i piedi posati di una statua di marmo, e molte, molte medaglie (monete ndr). Di più nello spianare il terrapieno per la fabbrica della chiesa fu trovata quasi in mezzo una cisterna quasi consimile all’altre due che stanno sul prato e fu fatta servire per sepoltura, essendovi anche in questa due cunicoli, come quelle accennate di sopra.”
Ancora la cronaca del convento, che porta la notizia del ritrovamento di due statue e della costruzione del recinto del convento nel 1771 (non sappiamo se l’intero recinto o quello che divide l’area del pianoro) ”… Che dette fabbriche fossero magnifiche… rilevasi dalla quantità di marmi ritrovati, parte serviti già per la chiesa, parte trasportati altrove… Quello che riguarda il tempio, non abbiamo memoria alcuna della sua figura. Sembra però che poteva rassomigliare al tempio del Sole che tutt’ora si vede nella piazza della Bocca della Verità e ciò si ricava dai pavimenti… Mentre in un certo sito detto presentemente il Cocchio vi fu trovato un mosaico rotondo finissimo, e all’interno di detto pavimento a Mosaico, altro mosaico ma più ordinario… Si vuole che la statua di Giove fosse di marmo e che fosse colossale e che nei scavi fatti circa l’anno 1714 su la sommità del monte fosse ritrovata, mancante però della testa, e che per l’ingiuria e la quantità dei secoli scorsi, fosse talmente scontraffatta e rovinata, che poco o niente potevasi riconoscere… Padre Tommaso… pretese di porre la clausura… benché non recintato fosse quest’orto. Forse per scavare con più libertà fece egli far questo Passo… il quale quest’anno (1771) trovò una statua che mandò al Pontefice Clemente XIV”.
La chiesa fu dedicata il primo ottobre del 1784, ma, secondo A. Nibby, non conteneva oggetti di particolare interesse, così come la casa annessa.
Da un carteggio del 1884 tra i Padri Passionisti di Monte Cavo e il Cardinale Camerlengo, nel quale i frati chiedono il permesso di scavare per trovare materiali antichi per costruire un campanile, il Cardinale risponde: “Il recinto di Monte Cavi, ove… desidererebbe praticare lo scavo per togliere alcuni macigni per servire alla fabbricazione del nuovo campanile, è il famoso recinto del tempio di Giove Laziale, composto di pietre tagliate in quadro, alcune delle quali sono ancora segnate da lettere antiche. Importa quindi all’erudizione e all’antichità che non sia toccato…”.
A questa nota i frati si riferiscono un anno dopo, sostenendo di “… non aver mai inteso di toccare quelle, che compongono il recinto dell’antico tempio, ma intendevano supplicare per poter scavare dentro li quadri dell’orto e prendere le pietre che i lavoranti nell’orto stesso, si sono accorti esservi sotterra…” A questa nota il cardinale vieta, nello stesso anno, qualunque intervento sia dentro l’orto che sul recinto. Ma le disposizioni del Cardinale non furono rispettate, come si evince da una sua lettera, purtroppo perduta, al Governatore di Albano che si riserva di verificare quanto accaduto.
(Sulla storia e cronache del Convento in rapporto agli scavi archeologici, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2021/04/22/monte-cavo-storia-e-cronache-del-convento/)
(Per l’identificazione dell’Arx Albana, spesso identificata con la vetta, ma recentemente ubicata alla Fortezza Pontificia, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2021/07/17/il-mito-di-rea-silvia-la-fortezza-pontificia-e-larx-albana/ )
Il temenos
Nel 1787 A. Riccy vide e misurò un grande recinto misurante m. 35×70 costituito da grandi blocchi di tufo, su uno dei quali compariva la scritta FULGUR. Inoltre, presso il lato corto meridionale, egli descrisse un arco che formava “una sorta di anticamera” purtroppo demolito dai frati. Nel 1820 A. Nibby vide e misurò anch’egli lo stesso recinto, fornendo le medesime dimensioni di Riccy: m. 35×70. Quattro anni dopo, il Cardinale Camerlengo menzionò le lettere scolpite sul recinto. Solo nel 1873, G. B. De Rossi rinvenne nel codice barberiniano vaticano un disegno seicentesco che nel frontespizio riporta la dicitura: Vestigia templi atque arx Jovis Latialis. Questo disegno si data attorno alla metà del XVII secolo e fa parte di una raccolta di dieci fogli (redatti probabilmente dalla stessa persona) che riproducono alcuni monumenti albani. Si tratta di un documento eseguito in parte con vista di prospetto oppure in pianta; ogni dettaglio è reso con molta cura, anche se il disegno non è in scala. Una didascalia illustra gli elementi che lo compongono: una strada lastricata che (allora visibile cento metri prima e interrotta nel disegno dove si ipotizza il suo ingresso nel recinto) dinanzi ad un muro in opera quadrata di quattro assise visto di prospetto, forse crollato nella parte centrale, che forma il lato corto di un grande recinto rettangolare reso in pianta. All’interno di quest’ultimo figurano un edificio absidato affiancato da una sorta di basamento, due ricorsi murari con andamento parallelo all’asse trasversale del recinto ed una vera da pozzo scanalata. Una “scalinata” composta da quattro gradini, il più alto a ridosso di un muro (?), appare all’esterno, adiacente al lato lungo del recinto, quello di destra.
Nella didascalia l’edificio absidato (A), spostato a sinistra, viene presentato come il tempio di Giove Laziale; la pianta è assai dettagliata, poiché lungo i muri appaiono in sequenza lesene, nicchie e basi di colonne; presso l’edificio absidato, accostato al recinto, appare quella che viene definita “base di un altare” (B). La profondità del recinto è resa all’interno in assonometria mediante tratti spaziati in modo regolare di difficile interpretazione; la strada lastricata che si avvicina obliquamente al lato corto del recinto, non è fiancheggiata dalle solite crepidini formate da umbones e gomphi, ma da muri forse formati da tre ricorsi di blocchi. Sul lastricato, forse a margine della strada, appare una “fossa” (G) che in apparenza immette in un ambiente sotterraneo profondo. Infine, il lato corto superiore non mostra alcuna articolazione in pianta, ma viene reso con una semplice linea.
Un’altra data cruciale risale al 1869, anno in cui i PP. Passionisti rinvennero i celebri frammenti marmorei dei fasti consolari, la lista dei consoli che, a partire dalla metà del V sec. a.C. (i decemviri), salirono sul Monte Albano per indire le ferie latine (in realtà, la lista marmorea è molto più tarda, probabilmente risale all’età augustea). Anche questo ritrovamento fu accompagnato dalla distruzione di una struttura, forse una platea più che un muro come intese M. S. De Rossi più tardi, se non addirittura l’edificio stesso che ospitava i fasti. Nell’insieme, è notevole la notizia del ritrovamento di mosaici e di edicole rotonde nei pressi della statua ritenuta di Giove, così come riportato nella cronaca del convento.
Gli scavi archeologici di M. S. De Rossi
Passiamo ai primi scavi. Nel 1869, in seguito al ritrovamento delle menzionate iscrizioni marmoree relative ai fasti consolari delle ferie Latine – come riferisce Guglielmo Henzen, Segretario dell’Instituto Archeologico Germanico – l’Instituto decise di finanziare gli scavi (durati all’incirca appena un mese dal 20 settembre 1876 alla fine di ottobre dello stesso anno) sotto la direzione di Michele Stefano De Rossi (egli ha esperienza di scavi archeologici, ma viene ricordato anche come scienziato: è il primo ad aver creato una scala di misura degli eventi sismici assieme allo svizzero Forel, scala che sarà modificata da Mercalli nel 1902). Quindi il mandato era relativo alla sola scoperta delle iscrizioni, ma non per la ricerca del tempio di Giove Laziale o di altri monumenti presenti sulla vetta. Egli è pertanto collegato al gruppo che pochi anni prima ha operato presso il tempio della Dea Dia e nel bosco degli Arvali che ha restituito lo straordinario “monumento epigrafico” che conosciamo (G. Henzen, R. Lanciani, il fratello G. B. De Rossi collabora scavando la vicina catacomba di Generosa).
Gli scavi di M. S. De Rossi portarono alla luce alcuni tratti della via lastricata nel tentativo di portare alla luce l’ultima parte del suo percorso (che prima dell’inizio dei lavori terminava sotto una macera a circa 100 m. dal grande recinto, il che spiega sia il carattere ipotetico dell’ultimo tratto di strada del disegno seicentesco che la medesima ipotesi accolta nella planimetria del De Rossi). Venne rinvenuta nei pressi della strada una grande cisterna, profonda quattro metri, larga tre e mezzo, che venne scavata solo in parte, per una lunghezza di circa venti metri. All’interno si rinvennero grandi blocchi squadrati e numerosi frammenti pertinenti a reperti di vari tipo, due dei quali, assai minuti e semi combusti, appartenevano ai fasti. Inoltre, venne ispezionato il pozzo, ugualmente riportato nel disegno secentesco (ma rinvenuto in una posizione ben diversa), che immetteva in un ambiente ipogeo rivestito in cocciopesto, largo tre metri e mezzo ed alto tre, da cui si innestava un cunicolo, alto m. 1.95 largo 0,95, con andamento sud ovest in direzione della menzionata cisterna (scavato solo in parte per una lunghezza di quindici metri). Dal fondo della cisterna, un altro cunicolo drenava l’acqua, sempre in direzione sud ovest, probabilmente incanalata in tubi di piombo derivanti da una cassetta di distribuzione recante alcune iscrizioni, rinvenuta in un incasso all’imbocco della grande cisterna.
Il tratto terminale sud orientale della via sacra mostra un accenno di biforcazione: un tratto di circa venti metri (ipotizzato da de Rossi) si dirige a nord est, quindi verso l’interno del pianoro (terminante dinanzi il recinto secentesco riportato in pianta, che però non era più visibile) tenuto a prato dai frati; un altro tratto di strada secondo De Rossi – postulato dalla presenza dei medesimi argini stradali già venuti alla luce lungo il lato meridionale della via sacra – sembrerebbe proseguire per almeno settanta metri in direzione sud est, piegando lungo il ciglio del pianoro. Sempre secondo De Rossi, questo ramo di strada doveva portare alla “gradinata” lunga settanta metri riportata nel disegno secentesco.
Molta attenzione venne rivolta all’area settentrionale e centrale del prato, dove, sempre nel disegno secentesco, venivano ubicati i due edifici indicati come il “Tempio di Giove Laziale” e la base dell’altare del tempio. In questa zona venne rinvenuto solo l’angolo sud orientale dell’edifico absidato (contrassegnato con la lettera A nel disegno secentesco): questa scoperta risulta fondamentale dal punto di vista topografico perché stabilisce planimetricamente una connessione sicura con il disegno in questione conferendo nel contempo validità alla collocazione spaziale del grande recinto misurante m 35×70. Anni dopo G. Lugli contesterà (in modo incomprensibile) questa esatta collocazione topografica (De Rossi pubblicò la planimetria in scala al contrario di Lugli), ponendo il recinto più a ovest. Lugli fondò le sue perplessità sul fatto che la fovea rappresentata nel disegno barberiniano presente nel lastricato della strada (lettera G) nel punto terminale della strada antistante il muro del recinto, fu in realtà trovata in un’altra parte: esattamente sotto la nuova strada di accesso all’area sommitale, dove ancora oggi la Sacra via si può osservare (termina sotto una breve galleria sottostante la strada). Le due realtà del De Rossi e di Lugli, apparentemente contradditorie, dimostrano invece che nel disegno secentesco si voleva semplicemente rappresentare il tratto terminale della Sacra via nel punto in cui allora affiorava e finiva sotto una macera, così come la trovò e descrisse il De Rossi prima di intraprendere gli scavi dei tratti successivi: infatti nel disegno secentesco appare un evidente segno di interruzione della strada.
Nel punto più settentrionale del recinto De Rossi ubicò nella planimetria di questi scavi una grande struttura a blocchi da egli vista e rilevata tempo prima, successivamente demolita dai frati, presso la quale forse erano stati rinvenuti nel 1869 i frammenti marmorei dei fasti. Nell’area centrale, dove i frati tra il 1869 e 1870 rinvennero grandi blocchi e una stipe votiva, vennero trovati altri resti sparsi di ex voto, tra cui un altro minuscolo frammento dei fasti.
Infine, parte di un ambiente a pianta rettangolare venne rinvenuto a meridione, presso la biforcazione delle due strade; esso era pavimentato a mosaico con tessere in bianco e nero, e recava sul lato sud una canaletta nella quale venivano disperse le acque piovane raccolte dal tetto.
Nell’insieme, questi scavi (durati all’incirca appena un mese dal 20 settembre 1876 alla fine di ottobre dello stesso anno) non portarono ai risultati sperati, come attesta lo scarno resoconto di Henzen nel corso della sua relazione tenuta nell’autunno dello stesso anno. I tre minuscoli frammenti dei fasti rinvenuti, due dei quali semi combusti rinvenuti sul fondo della cisterna, segnavano l’evidente fallimento degli obiettivi che avevano condotto a quella breve campagna di scavi.
Nonostante queste considerazioni, nello stesso anno, M. S. De Rossi sottolineò, a ragione, l’importanza di quegli scavi. Nella planimetria pubblicata venne sovrapposta la pianta seicentesca del codice Barberini opportunamente modificata (in base però a calcoli del tutto arbitrari). Ma nell’insieme, gli scavi del De Rossi hanno ottenuto alcuni risultati molto importanti.
Il primo è senz’altro quello del ritrovamento delle cassette plumbee di distribuzione dell’acqua. I consoli citati nell’iscrizione di una di esse, nella quale si legge Max Tub Cos, sono Paolo Fabio Massimo e Quinto Elio Tuberone, i quali hanno ricoperto quella magistratura nell’anno 11 a.C., data in qualche modo collegata con le leggi sulle acque di quel periodo; non è un caso che questi due consoli vennero più volte menzionati da Frontino in relazione a senati consulti da essi emessi per questa ragione in età augustea.
De Rossi constatò che il calcolo della portata d’acqua espresso in quinarie, se riferito ad alcune lettere dell’iscrizione di una delle cassette, era esorbitante; se addirittura venivano sommati i numeri delle due cassette si superavano le mille quinarie (circa 500 litri al secondo). Alla fine egli si arrese dinanzi al fatto che entrambe le iscrizioni erano frammentarie e che pertanto quei numeri, almeno in parte, potevano avere altro significato e la sua conclusione fu che in quella cisterna, da sola o assieme ad altre, doveva transitare molta acqua.
Dunque, il dato più importante e significativo risulta dal fatto che l’acqua erogata era aqua publica e quindi destinata solo ed esclusivamente a edifici pubblici, come dimostra anche l’altra iscrizione delle cassette di distribuzione di piombo che menziona il magistrato erogatore di quelle acque, un curator aedium sacrarum, cioè il curator aedis sacrae del Monte Albano, in questo caso responsabile dell’acqua raccolta dall’area sacra di Giove Laziale.
La scoperta è davvero importante per noi, dal momento che l’unico edificio pubblico a valle della cisterna – posta presso il ciglio del pianoro da cui si dipartiva la tubazione plumbea nel cunicolo discendente ispezionato e ben pubblicato in sezione da De Rossi – non poteva che essere il ninfeo di Prato Fabio annesso con ogni probabilità al tempio/sacello di Venere. Inutile aggiungere che il console Paolo Fabio Massimo, è menzionato da Orazio che lo collega appunto con il culto di Venere praticato sul Lago Albano (vedi infra).
Sono molti altri gli spunti che emergono dagli scavi di De Rossi o dalle sue osservazioni. Una di queste riguarda il recinto sacro del tempio inteso come bacino di raccolta delle copiose acque piovane convogliate nella grande cisterna attraverso un pozzo. In linea di massima, in assenza di sorgenti, queste argomentazioni possono essere attendibili, ma dal punto di vista idraulico le difficoltà sono evidenti: raccogliere acque piovane da un’area così vasta e convogliarle in un solo pozzo è impossibile senza la presenza di un lastricato pavimentale con le dovute pendenze (in caso contrario, il terreno vegetale avrebbe assorbito totalmente l’acqua piovana). Questa osservazione di De Rossi introduce però il tema fondamentale, la vera questione spinosa rimasta sostanzialmente ancora aperta: quella del temenos, del grande recinto sacro.
Innanzitutto, egli chiarisce, sicuramente a ragione, che l’edificio absidato – rappresentato in alto nel disegno secentesco barberiniano (definito Tempio di Giove) – individuato e parzialmente messo in luce in corso di scavo, potrebbe essere in realtà una chiesetta dedicata a San Pietro, nota già da documenti del 1592. Anche la sua intuizione in merito alla “gradinata” lunga ben settanta metri, raggiungibile dalla strada da lui ipotizzata, intesa come diramazione verso est della via sacra, potrebbe essere corretta. Ma per quanto riguarda la sommità della “gradinata”, quando egli osserva giustamente che il disegno secentesco riporta in assonometria la profondità del recinto all’interno, non si rende conto che essa può essere stimata attorno ai tre metri (sopra il piano di campagna del sei – settecento naturalmente) e che la parete verticale interna inizia proprio dal margine del muro (?) alle spalle del gradino più alto. Questa altezza è certa, poiché viene riferita dall’Abate Riccy, quando stima la dimensione di ciascun blocco del muro meridionale alto tre palmi, oltre sessanta centimetri. E le assise del muro meridionale del disegno secentesco – lo stesso di cui parla Riccy – sono ben quattro.
Dunque non è affatto una “gradinata” che dovrebbe condurre all’interno (lunga addirittura settanta metri!) ma, al contrario, potrebbe essere considerata a tutti gli effetti una tribuna rivolta all’esterno, sempre che il disegno secentesco sia attendibile ovviamente. Su questo argomento torneremo trattando della cd. “Casa dei Consoli” rinvenuta successivamente da Giuseppe Lugli di fronte alla (presunta) tribuna in questione ed avente (a quanto pare) lo stesso orientamento.
Le numerose difficoltà incontrate durante questo scavo, tanto breve quanto orientato alla sola ricerca di documenti epigrafici, emergono sistematicamente soprattutto a livello stratigrafico, poiché dalle relazioni non emerge alcun dato di fondazione, essenziale in caso di spoliazioni. Di fatto, del recinto, tribuna compresa, non abbiamo nessuna testimonianza archeologica scientificamente valida, per cui non sappiamo assolutamente nulla. E ciò vale per tutti gli edifici sacri descritti dalle fonti antiche presenti sul Monte Albano. Riguardo a ciò, De Rossi convenne che l’edificio dedicato a Giove doveva trovarsi al centro del grande recinto sacro e che forse poteva coincidere con l’edificio rappresentato nel disegno secentesco come “base dell’altare”; quindi non un tempio vero e proprio, ma una sorta di cella con altare del dio. De Rossi concluse asserendo che il temenos, il grande recinto visto da Riccy e Nibby, costituiva “l’area sacra con l’ara nel mezzo, ossia un templum di rito e forma primitiva semitica, pelasgica ed italica”.
Scavi di G. Giovannoni e C. Ricci del 1912-1914 (mai pubblicati)
Iniziati ai primi di settembre del 1912, non furono mai pubblicati. Di essi, non abbiamo alcuna planimetria, tranne una scarna relazione di Giovannoni apparsa su Notizie Scavi del 1912 (G. GIOVANNONI, Esplorazioni nell’area del tempio di Giove Laziale, in «NSA» 1912, pp. 382-384). Il punto di partenza di quegli scavi, a detta dello stesso Giovannoni “… fu dato dal ritrovamento compiuto dal sottoscritto di tutta una serie di 16 tamburi di colonna… di pietra tufacea… aventi diametri variabili… tra m. 1,35 e m. 1,16 che qua e là appaiono nelle vallate sottostanti al versante meridionale del monte Cavo…). Giovannoni si disse sicuro che questi rocchi “trovati qua e là” (sic!) non potevano essere che le colonne del pronao di un grande tempio “… che non può essere altro che il tempio di Giove Laziale; e bastano a distruggere l’ipotesi che questo appartenesse ad un rito semitico (avanzate in precedenza da De Rossi ndr). Sicuro delle sue convinzioni, scavò su un “contrafforte avanzato verso mezzogiorno” e poi su quello che forse poteva essere, almeno secondo lui, un terrazzamento antico (ubicato anche questo da qualche parte di Monte Cavo). Ma, come ebbe a dire poi “L’una e l’altra ricerca ebbero esito negativo”.
Non potendo “distruggere” le ipotesi di De Rossi, egli passò pertanto alla “seconda fase delle indagini” che fu rivolta “… alla determinazione del tracciato della via Triumphalis nell’ultimo tratto”. Giovannoni specifica che questi nuovi scavi, eseguiti nello stesso posto in cui scavò in precedenza De Rossi, vennero però effettuati con “criteri diversi”. Infatti, le nuove strategie permisero di stabilire che “Riapparve nell’ultimo tratto la via antica evidentemente rialzata e rinnovata in tempo tardo… avviantesi… sullo stesso asse (longitudinale ndr) della lunga cisterna già determinata dal De Rossi”.
Innanzitutto venne messa in seria discussione la validità della planimetria di De Rossi (redatta in scala ed orientata), in particolare nel punto cruciale che riguarda il tratto terminale della via sacra; nella planimetria infatti, il quarto saggio della strada mostra un tratto di basolato (rinvenuto nel medesimo scavo che ha messo in luce anche la cisterna come mostra l’alone che perimetra entrambi i siti) che indica l’andamento divergente del tracciato stradale rispetto alla grande cisterna (come dovrebbe essere). Giovannoni invece, oltre trent’anni dopo, trova una strada “rialzata e rinnovata”, che si arresta davanti al lato breve occidentale della cisterna (non sappiamo se interrata o meno), il cui andamento segue esattamente l’asse longitudinale della conserva d’acqua. E’ evidente che si tratta di una strada moderna che non ricalca affatto il percorso antico della via sacra: sarebbe demenziale il solo immaginare una cosa di questo genere. Quello che non si comprende è la planimetria finale degli scavi redatta circa vent’anni dopo da Lugli (che ha scavato con Giovannoni): la via sacra viene fatta terminare a ridosso del lato breve della cisterna, mentre nella planimetria non appare nessuna trincea eseguita a fianco della cisterna (a sud), come minimo resasi obbligatoria per verificare sia l’attendibilità degli scavi di De Rossi che l’eventualità che la via sacra abbia continuato il suo percorso. Questa grave omissione aumenta le nostre perplessità per il fatto che Lugli (e Giovannoni) non si sono mai posti il problema del modo in cui la via sacra, o una sua diramazione, abbia raggiunto l’edificio da loro rinvenuto all’estremità orientale del pianoro (la cd “Casa dei Consoli”).
Giovannoni prosegue la descrizione dei suoi scavi, purtroppo senza alcun riferimento topografico preciso: “Resti notevolissimi di grandi fabbricati… gli uni che principalmente occuparono la parte nord ovest, appartengono al tempo di Tiberio… gli altri nella zona est poggianti su una piattaforma di grande spessore ed appartenenti probabilmente al secolo III” (alcune di queste annotazioni riguardano il rinvenimento delle prime strutture relative alla cd. “Casa dei Consoli” finita da scavare nella successiva campagna di scavi del 1929).
Molte tombe alla cappuccina o a cassettone di età tiberiana di secondo secolo furono rinvenute “… nel clivo immediatamente sottostante alla sommità nel versante meridionale…”. Lugli successivamente smentì (giustamente) queste datazioni, attribuendo queste tombe ad un periodo tardo.
Una considerazione importante di carattere stratigrafico viene ribadita infine da Giovannoni, quando riferisce della presenza di potenti rinterri di cinque o sei metri “nella parte centrale”, lamentando l’impossibilità di operare in quella zona “in assenza di mezzi tecnici e finanziari idonei”; egli scrive poi che “in quell’area, se ancora esistono, potrebbero trovarsi i resti repubblicani”. Si tratta quasi certamente dell’interno del temenos. Quindi, il fatto che non si arrivò mai al livello pavimentale, sicuramente lastricato, è dovuto ai forti rinterri e ciò fa sperare che ancora oggi, qualcosa si sia conservato nonostante la devastazione dell’area patita in questi ultimi tre decenni.
Scavi del 1929 di G. Lugli e G. Giovannoni
Eseguiti nel mese di ottobre del 1929 con un sussidio del Ministero della Educazione Nazionale, i lavori impiegarono dodici operai per tre settimane. Nel succinto resoconto di questi scavi, pubblicato nel 1930 (G. LUGLI, Saggi di scavo per la ricerca del tempio di Giove sulla vetta di Monte Cave, in «BA» ottobre 1930, anno IX, pp. 162-168), Giuseppe Lugli premette le finalità di quelle indagini, spiegando che esse hanno proseguito ed ultimato gli scavi della vetta di Monte Cavo effettuati da Michele Stefano De Rossi e “… quelli più accuratamente condotti dal Prof. Giovannoni, competentissimo… alla distanza di sedici anni dai suoi lavori (scavi 1912-14 ndr) il lavoro è stato ripreso per impulso dello stesso Prof. Giovannoni il quale ne darà a suo tempo una relazione completa”.
Ma poiché ancora una volta il “competentissimo Prof. Gustavo Giovannoni” non pubblicherà nemmeno gli scavi del 1929, dobbiamo accontentarci – anche per questa campagna di scavi – delle brevi anticipazioni di Lugli, come vedremo del tutto insufficienti, riportate sulla sua “piantina schematica” come definisce egli stesso la planimetria pubblicata, eseguita quasi a “mano libera”.
Queste precisazioni si rendono assolutamente necessarie perché è assai probabile che questa “piantina schematica” eseguita tra l’altro fuori scala, riassuma sia gli scavi Giovannoni del 1912-1914, mai pubblicati, che quelli diretti da Lugli del 1929, anche questi privi sia di una corretta documentazione topografica che scientifica. Infatti, le dodici trincee scavate a varie profondità (m. 0,90 e m. 1,60), il grande edificio orientale (la cd. Casa dei Consoli) del quale vennero scavati anche pavimenti, pozzi e cunicoli per parecchi metri ecc., i vari accertamenti eseguiti anch’essi in profondità sotto il recinto dei frati (trincee contrassegnate con le lettere op e mn), non possono assolutamente essere ricondotti al lavoro di dodici operai per tre settimane. Questa convinzione è naturalmente avvalorata dal fatto che lo schizzo di Lugli comprende anche il tratto finale della via sacra che si arresta davanti alla grande cisterna, descritto in precedenza da Giovannoni (G. GIOVANNONI, Esplorazioni nell’area del tempio di Giove Laziale, in «NSA» 1912, pp. 382-384).
Nel riassumere tutte queste attività, Lugli critica la validità del documento seicentesco del Codice Barberini, il quale, a suo dire, “non solo non aiuta, ma complica le idee”. Questa certezza viene fornita, sempre secondo Lugli, dagli scavi del Giovannoni effettuati attorno al convento e nell’orto dei frati, i quali hanno qui escluso la presenza del basamento di un tempio. Nella cartina egli riporta una serie di trincee sparse in vari punti, alcune delle quali contrassegnate da lettere, altre senza, nelle quali vennero trovati “alcuni muri, una cisterna, due pozzi e il proseguimento della strada entro l’orto per alcuni tratti” (allusione agli scavi Giovannoni del 1912).
Più in generale, Lugli osserva che per una distanza di 45 metri tutto intorno al convento è apparsa la base geologica formata da “lapillo” o “cenere grigia”. In queste aree, in particolare ad ovest del convento, furono rinvenuti “… tronconi di muri in cattivo laterizio in tutto simili agli altri rinvenuti nel 1914 indizio di fabbriche del tardo impero per uso civile” (datati invece da Giovannoni all’età tiberiana). Lugli annota anche che furono eseguiti due piccoli saggi anche nelle cantine del convento, profondi 30 cm., ma non fu rinvenuto nulla.
L’approssimazione degli scavi attorno al convento, che si accompagna a quella della datazione tarda relativa alle poche strutture rinvenute, pertinenti ad abitazioni tardo antiche o ancora più recenti, hanno alimentato la convinzione di Lugli che in tutta quell’area non ci fosse nulla di particolare; ma come abbiamo visto, questa sua ipotesi è stata decisamente smentita dalla cronaca annuale del convento (rinvenuta da Claudia Cecamore negli anni ’90 (C. CECAMORE, Il santuario di Iuppiter Latiaris sul Monte Cavo: spunti e materiali dai vecchi scavi, in «BCAR» XCV, 1993, p. 20; eadem: , Nuovi spunti sul santuario di Iuppiter Latiaris attraverso la documentazione d’archivio, in Alba Longa Mito Storia Archeologia, cit., pp. 49 – 66, Tavv. I, II, figg. 2, 3, 4.) in occasione della costruzione della nuova ala e della chiesa
Il resoconto di Giovannoni del 1912 del ritrovamento di “… grandi fabbricati… nella zona est poggianti su una piattaforma di grande spessore ed appartenenti probabilmente al secolo III”, viene richiamato da Lugli quando spiega che gli scavi del grande edificio posto presso il ciglio orientale del pianoro completano quelli intrapresi da Giovannoni. Ma ancora una volta corregge la datazione proposta a suo tempo da Giovannoni: il porticato eseguito con blocchi a secco da lui messo in luce non sarebbe di III secolo d.C. ma, secondo Lugli, esso “era assai antico”, già scomparso nel II sec. d.C. quando ad esso venne addossato l’edificio più tardo.
A questo proposito diventa del tutto incomprensibile il curioso silenzio di Lugli attorno ai sedici grandi rocchi di colonna menzionati da Giovannoni a suo tempo, attualmente irreperibili. La loro posizione poteva (e doveva) ora essere ubicata con precisione, dal momento che tutto il pianoro di Monte Cavo offriva negli anni ’30 molti punti di riferimento sicuri, in particolare presenti presso il ciglio meridionale lungo circa cento metri. Per cui, i grandi rocchi rivenuti “qua e là” “… nelle vallate sottostanti al versante meridionale del monte Cavo…” potevano dare indicazioni importanti. Ad esempio, se rinvenuti ad oriente, potevano benissimo essere messi in relazione all’antico portico apparso attorno alla cd “Casa dei Consoli”, presso il quale furono trovati, a intervalli regolari lungo il lato est, grandi basamenti atti a sostenere un colonnato, come ammise lo stesso Lugli. E la dispersione delle colonne nelle vallecole sottostanti potrebbe essere messa in relazione alla totale distruzione (come spiega Lugli) del lato meridionale dell’edificio e quindi probabilmente del porticato perimetrale annesso.
Un altro elemento importante riguarda i muri rinvenuti nella trincea menzionata (op). Lo scavo venne effettuato sotto i grandi blocchi di tufo che delimitano il recinto dei frati, posti lungo il ciglio del pianoro, in evidente giacitura secondaria. Al di sotto (non sappiamo di quanto) vennero rinvenuti tratti di muro ancora in situ composti da quattro filari di blocchi ben connessi e con entrambe le facce bugnate. Detti blocchi hanno una lunghezza media di m 1,90 – 2,10 ed alcuni arrivano ad una lunghezza di oltre 3 metri. Mancano elementi di datazione certa; secondo Lugli non sono di epoca repubblicana, ma più recenti e comunque “risalgono genericamente all’epoca antica“. Ciò nonostante, egli sembra concludere che il nuovo recinto dei frati possa in qualche punto coincidere con l’antico recinto repubblicano.
La sommità del Monte Albano che ha ospitato l’area sacra fin dai tempi più antichi si eleva a circa 950 m. s.l.m. e si estende per circa 1,5 ha. Il punto più alto dell’area risulta essere quello del ciglio orientale, quello più basso, di circa quindici metri, è quello occidentale dove si trova il convento. L’unica area pianeggiante è quella centrale, dove, secondo Giovannoni, fu impossibile scavare a causa di potenti rinterri di cinque o sei metri; egli lamentò l’impossibilità di operare in quella zona “in assenza di mezzi tecnici e finanziari idonei”.
Come abbiamo visto, delle tre campagne di scavo condotte sulla vetta di Monte Cavo, le ultime due rimangono sostanzialmente inedite. Il quadro topografico generale che ne deriva è assai confuso e contradditorio; nonostante l’infinità di trincee eseguite e di scavi effettuati ovunque (non sapremo mai dove), ancora oggi non conosciamo nulla del tempio (?) di Giove Laziale, di quello di Giunone Moneta, dei culti più antichi, dei vari sacelli e di altre realtà cultuali (si pensi all’eventuale presenza di un Auguraculum per esempio), dell’articolazione dell’area sacra e delle strade di vari periodi.
In generale, un punto fermo riguarda la presenza di un temenos. Il grande recinto fu riportato nel disegno del Codice Barberini, venne visto e misurato in tempi diversi da Riccy e Nibby, che lo stimarono lungo circa m 70×35, mentre il Cardinale Camerlengo lo menziona ancora integro nel 1824; della sua sicura costruzione in età repubblicana furono convinti sia M. S. De Rossi che Lugli.
Un’altra certezza riguarda il medesimo orientamento nord sud – est ovest di tutte le strutture più importanti emerse dalle varie campagne di scavo, come l’edificio orientale (la cd. Casa dei Consoli) e la grande cisterna scavata in parte dal De Rossi, ai quali va aggiunto il terzo ambiente rettangolare con pavimento a mosaico orientato come i precedenti (rinvenuto dal De Rossi a sud della cisterna) apparentemente isolato ma sicuramente collegato funzionalmente agli spazi vicini. Di questo insieme di strutture orientate tutte nello stesso modo, stranamente, Lugli e Giovannoni non tennero conto. Pertanto ora sappiamo perché tutti questi edifici furono orientati come il grande temenos: essi erano funzionali a quell’area sacra principale, vennero costruiti dopo di essa e la circondarono. Possiamo anche dire che la posizione e l’orientamento del grande recinto rettangolare vennero quindi correttamente ubicati da De Rossi nella parte centrale della vetta, anche se, ovviamente, è possibile che la sua ricostruzione necessiti di piccoli correttivi. Uno di questi riguarda la posizione della grande cisterna, sicuramente costruita all’esterno del temenos molti secoli dopo di esso; la presenza nel suo interno della cassetta di distribuzione dell’acqua recante l’iscrizione dei consoli dell’11 a.C. garantisce che in quel periodo la cisterna era voltata, il che esclude il passaggio della strada lastricata sopra di essa, come ipotizzò De Rossi. Inoltre, anche la posizione della cisterna sotto l’angolo del temenos, parzialmente costruita all’interno del recinto stesso, non convince.
Il suggerimento di Lugli (in realtà piuttosto velato) in base al quale il temenos possa coincidere invece con il breve tratto di muro da lui rinvenuto lungo il ciglio del pianoro dove si trova il recinto dei frati (trincea op) non può essere accolto per numerosi motivi. A cominciare dal fatto che, come lui stesso del resto ammette, il muro in questione (con entrambe le facce bugnate) non è affatto di età repubblicana ma più recente. Inoltre, in questo punto l’area è in netta pendenza (da sud est a nord ovest); per di più, all’interno del recinto sacro verrebbero a trovarsi sia la via sacra – che in questo caso l’attraverserebbe due volte per raggiungere sia la cd. Casa dei Consoli – che la grande cisterna, cosa assolutamente impossibile. Inoltre Lugli specifica che attorno al convento, per un tratto di 45 metri, non ha trovato alcuna struttura, poiché in quell’area appare solo lo strato vergine di lapillo. Le obiezioni sono molte altre e tutte valide, basta scorrere il resoconto annuale dei frati per incontrare altre cisterne o manufatti incompatibili con il recinto dell’area sacra.
Il disegno secentesco del Codice Barberini è reso in modo schematico, per cui nell’insieme va accolto e interpretato con molta prudenza. Vi appare il recinto sacro, la cui presenza è sicuramente accertata così come quella del muro a blocchi sul lato breve in primo piano descritto e misurato da Riccy. Per quanto riguarda invece la curiosa “scalinata” lunga settanta metri che si addossa al recinto, nessuno se n’è occupato, forse perché costituisce un dettaglio imbarazzante e difficile da commentare, tale da poter addirittura togliere credibilità all’intera rappresentazione del disegno. La sua palese inutilità potrebbe aumentare il sospetto che sia il prodotto di una banale invenzione, anche perché quella gradinata non porta da nessuna parte: risulta chiaramente che si arresta sul bordo del recinto, dinanzi all’area sacra, ma a tre metri di altezza rispetto al piano interno sottostante (il piano di campagna di due secoli fa).
Sappiamo che durante le ferie Latine convenivano sul Monte Albano numerose delegazioni dei popoli latini, una cinquantina secondo Plinio in età repubblicana, probabilmente molte di più successivamente. Accanto ad esse salivano i consoli con molti rappresentanti delle magistrature romane; alle celebrazioni ufficiali partecipavano i vari collegi sacerdotali, i curatori dell’area sacra, i vittimari, gli addetti alle cerimonie della comunione e visceratio, ecc.
Dunque, alcune centinaia di persone affollavano la vetta e, presumibilmente, ciascun gruppo doveva assistere od officiare nell’ambito di spazi prestabiliti. E’ pertanto possibile che sulla tribuna prendessero posto i rappresentanti delle varie delegazioni, mentre i consoli e magistrati romani sedessero di fronte, in un’altra tribuna allestita presso la cd. Casa dei Consoli, in un’area non ancora scavata da Lugli. In questo caso le cerimonie dovevano svolgersi nello spazio pianeggiante compreso tra le due tribune.
Sulla presenza di un edificio posto sul Monte Albano che ospitava i consoli durante i giorni in cui si celebravano le ferie Latine ci informa Dione Cassio (Cass. Dio LIV 29, 7). Egli ricorda infatti che, durante le ferie, un fulmine colpì quell’edificio proprio quando i consoli vi risiedevano all’interno. Che esso sia quello rinvenuto all’estremità orientale di Monte Cavo è assai probabile, anche perché sembrerebbe che in origine fosse circondato da un portico importante, ornato con grandi colonne, forse quelle menzionate da Giovannoni, delle quali non si ha più notizia.
Se abbiamo colto nel vero, l’articolazione spaziale della vetta di Monte Cavo potrebbe essere chiarita nelle sue parti principali. L’ultimo tratto della via sacra risale la spianata verso est fino all’area delle cerimonie, affiancata da un muro eretto lungo il ciglio meridionale (con entrambe le facce bugnate). Secondo gli scavi e le ipotesi di De Rossi, un ramo si dirige verso il recinto sacro (ma è del tutto ipotetico: è possibile che già nel disegno seicentesco il tratto di strada basolata antistante il temenos fosse ipotetico, poiché la strada affiorava cento metri prima secondo la planimetria disegno del De Rossi), l’altro prosegue fino all’area della gradinata.
Purtroppo, nulla sappiamo dell’assetto stradale arcaico. La strada arcaica sottostante il lastricato repubblicano, identificata da chi scrive e della quale è stata data notizia recentemente, non viene mai menzionata dagli autori delle tre campagne di scavo. La via lastricata, per qualche centinaio di metri, ancora prima di raggiungere la sommità, segue un percorso in trincea; a quanto pare, lo stesso avviene anche sulla vetta, dal momento che tutte le fonti, a partire dal disegno secentesco, menzionano la presenza di blocchi di tufo ai lati della strada, oltre le crepidini, atti a sorreggere il terrapieno. Segno evidente che l’ultimo tratto della via si sviluppava in trincea, come avviene quasi sempre per le strade arcaiche semplicemente scavate nel banco tufaceo, e forse questo potrebbe significare che le due strade, nell’ultimo tratto, erano sovrapposte. Le diverse interpretazioni fornite da De Rossi e Giovannoni – Lugli proprio sull’assetto stradale in prossimità del recinto sacro, nascono probabilmente, almeno in parte, anche dal fatto che in tutti i casi non si distinsero le varie fasi costruttive delle strade.
Per gli scavi archeologici condotti sulla vetta del Monte Albano e numerosi altri argomenti connessi, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2017/12/18/storia-di-alba-e-del-monte-albano-rassegna-degli-scavi-archeologici-sul-monte-albano/)
PARTE
VI
Il Prato Fabio e i Fabi
Il promontorio aggettante di Prato Fabio, a ovest termina a picco sul Lago Albano (posto a circa 500 metri al di sotto), si dispone su due livelli. Nel 1920 gli sterri per la costruzione di un villino e relativa dependance misero in luce alcune strutture antiche poste all’estremità occidentale del pianoro di Prato Fabio. Non fu redatto al momento alcun rapporto di scavo, né una planimetria generale, per cui non sappiamo nulla di ciò che avvenne materialmente nel cantiere, tranne qualche scarno appunto di Edoardo Gatti che allora operava nella Regia Soprintendenza agli Scavi di Roma in qualità di Disegnatore principale.
Gatti elenca brevemente (E. GATTI, Rocca di Papa, scoperte in vocabolo “Prato Fabio”, in «NSA» 1926, p. 406,407) il ritrovamento di una conserva d’acqua circondata da muri e di un tratto di strada lastricata, distante 50 m. da essa, che si raccordava alla via principale per il Monte Albano (detta Via Trionfale). Ma nell’articolo egli non menziona affatto la presenza di un altare (Archivio Gatti, Tacc. 179-185, 1920-1921; disegni del 1926 nn. 182, 183, 184, 185), che rappresenta invece in assonometria negli appunti di scavo assieme ad altri elementi del ninfeo: una omissione grave e del tutto incomprensibile. Emerge chiaramente la fortissima valenza cultuale del luogo, postulata anche dalla maestosa posizione del ninfeo, costruito nel punto più aggettante del pianoro di Prato Fabio che domina il Lago Albano.
Forse non siamo lontani dal vero se immaginiamo alle sue spalle la presenza del tempio/sacello di Venere menzionato da Orazio, quando, invocando la dea, la supplica di stornare da sé le pulsioni amorose e di indirizzarle verso Paolo Fabio Massimo che le porrà “…una statua di marmo sotto un tetto di citrus presso il lago Albano”. Non è solo la straordinaria posizione del ninfeo e del probabile tempio annesso a suggerire questa ipotesi, ma una serie di dati quanto mai significativi che collegano direttamente la gente Fabia a questo luogo, tanto da essersi cristallizzati nel toponimo di Prato Fabio.
L’aspetto più importante e certamente più noto, è quello legato al ruolo di Venere intesa come Genitrice della gente Giulia. Ad iniziare da Cesare, il quale inaugurò il culto di Venere Genitrice – madre di Enea, il padre di Ascanio fondatore di Alba Longa (detto anche Iulo, progenitore della gens Iulia, legittimando le origini divine della gente Giulia, che si ricollegano direttamente a Venere e Marte (padre di Romolo e Remo) emerge decisamente la figura di Paolo Fabio Massimo – console nell’11 a.C. imparentato con Augusto (ne aveva sposato la cugina Marcia) e intimo dell’imperatore, tanto da condividere con i Giuli la discendenza da Venere; l’accenno oraziano consente di avanzare l’ipotesi, a questo punto del tutto legittima, che l’erezione di un tempio/sacello dedicato a Venere (Genitrice) al Prato Fabio in età augustea sia stata voluta e realizzata da lui. Un indizio decisivo in tal senso riguarda la scoperta, sulla vetta del Monte Albano, delle cassette plumbee di distribuzione dell’acqua (pubblica, si badi bene) evidentemente convogliata nel sottostante ninfeo; inoltre questi due consoli sono stati più volte menzionati da Frontino in relazione a senati consulti da essi emessi per questa ragione in età augustea. La preziosità del tetto in legno di tuja del tempio/sacello – a meno che quella di Orazio non sia solo una divagazione poetica -, sottolinea la volontà di onorare con grande magnificenza la divinità capostipite della dinastia albana (e della Gente Iulia).
Pseudo Acrone ci informa inoltre dei (presunti) possedimenti di Paolo Fabio Massimo nella zona del Lago Albano. Infatti, sua moglie Marcia, era figlia di Azia minore, originaria di Ariccia, città illustre e famosa che si trova appunto presso il bordo del Lago Albano. E Azia minore era sorella di Azia maggiore, madre dell’imperatore Augusto, anch’essa aricina.
Concludendo, nonostante tutte queste testimonianze frammentarie, una cosa è certa: l’area di Prato Fabio potrebbe conservare ancora una delle pagine di storia più importanti relative alle origini di Roma e del Lazio antico. Ora sappiamo che una parte importante e fondamentale della tradizione antica relativa alle celebri vicende dei reges Albanorum e degli dei del Monte Albano, alludeva ad eventi che si irradiavano tutti dal medesimo luogo; ciò spiega la forza e la straordinaria intensità propulsiva che plasmò ogni momento della formazione storico-religiosa dell’ethnos latino così come trasmesso con dovizia di particolari dalle fonti antiche.
La separazione, tutta moderna, di Alba Longa dal Monte Albano, ha reso irriconoscibile e gettato nell’ombra anche l’intero portato della civiltà albana e provocato la dispersione dei suoi principali tratti culturali, relegati in un arcipelago concettuale confuso e totalmente incomprensibile sia sotto il profilo archeologico che storico.
(Sugli scavi condotti a Prato Fabio, il ninfeo e varie interpretazioni annesse, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2021/04/16/prato-fabio-alba-longa-scoperto-il-tempio-di-venere/)
PARTE
VII
L’ubicazione di Alba Longa
La recentissima scoperta del bosco sacro di Giove Laziale si rivela pertanto di straordinaria importanza poiché le sue delimitazioni sacrali coincidono perfettamente con la morfologia del Monte Albano, così come veniva intesa nell’antichità, la quale corrisponde a sua volta con la moderna definizione di Monte Cavo.
Quindi, la configurazione sacra di tutto il Monte Albano, fino alle sue pendici, diventa dper noi fondamental, poiché ora sappiamo che il maestoso promontorio di Prato Fabio era evidentemente estraneo al Monte Albano, sia a livello giuridico sacrale che dal punto di vista morfologico. In questa nuova prospettiva si comprende perché la versione di Tito Livio sia stata equivocata e che ora appare sotto una luce totalmente diversa. Innanzitutto egli non ha alcun bisogno di ubicare il luogo dov’era sorta Alba Longa, poiché tutti lo conoscevano. Inoltre quando cita il Monte Albano, non sta genericamente alludendo alla morfologia di un monte qualsiasi, ma ad un contesto sacrale, chiuso, unitario, che si estende ininterrottamente dalla vetta fino alle pendici, avvolto e delimitato dal grandioso e inviolabile bosco Sacro di Giove Laziale.
Sappiamo inoltre che la delimitazione giuridico sacrale del bosco sacro coincideva esattamente con le pendici del Monte Albano dove iniziano immediatamente le iscrizioni del clivo consacrato. Pertanto risulta chiaramente che tutto il famoso passo venne semplicemente concepito da Livio per spiegare perché Alba ricevette l’appellativo di Longa: “per la particolare forma che assume, alle pendici del Monte Albano, lungo il dorso della montagna” come egli scrive, dove si estende solo il promontorio di Prato Fabio.
Anche Dionigi allude palesemente al promontorio di Prato Fabio, quando descrive Alba Longa in posizione forte, strategica, difesa dalle sue stesse propaggini che fungono da mura.
Ma l’ubicazione più precisa di Alba Longa la fornisce in modo inequivocabile Porcio Catone, un tuscolano, che da Tuscolo vedeva il sito di Alba Longa tutti i giorni, la cui descrizione probabilmente compariva nel primo libro delle Origines. Quando spiega che il Monte Albano prende il nome da Alba Longa, egli sta menzionando un toponimo, e come tale, obbligatoriamente, il nome del luogo (Monte Albano) e la località da cui prende il nome (Alba Longa) debbono coincidere perfettamente a livello spaziale.
(Sull’identificazione del sito di Alba Longa, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2017/10/19/finalmente-identificato-il-sito-di-alba-longa-rocca-di-papa/)
(Sui re – antenati, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2022/05/26/i-re-di-alba-longa-la-dinastia-degli-antenati-mitici/)
PARTE
VIII
La stratificazione secolare della “casa degli dei” e della “casa dei re”.
In conclusione, un punto fondamentale riguarda il fatto (purtroppo del tutto trascurato o storicamente sottovalutato dagli studiosi) che questi luoghi si trovano all’interno del territorio albano e che nel corso dell’età protostorica – esattamente come in tutti i centri laziali di questo periodo delimitati da precisi confini (in particolare nella seconda età del ferro tra VIII e VII sec. a.C.) – Alba e il Monte Albano erano luoghi di culto rigorosamente riservati e accessibili solo dagli Albani. Infatti, con la formazione delle curie gentilizie (VIII – VII sec. a.C.), ciascuna posta all’interno dei rispettivi confini, Alba e il Monte Albano divennero probabilmente “spazi comunitari albani”. Anzi, in questo periodo, questi luoghi rispecchiano storicamente la risultante del millenario processo d’integrazione delle genti albane.
Solo con la successiva formazione delle città albane (VI sec. a.C. circa –Tuscolo, Ariccia, Lanuvio, Velletri e Labico) ed il loro rapporto con le altre genti latine (Roma compresa ovviamente), Alba e il Monte Albano acquistano la loro straordinaria sacralità all’interno del nomen Latinum nelle istituzioni come le ferie Latine e la lega latina. In questa nuova prospettiva si evidenzia, nei due spazi contigui, il culto comunitario delle nascenti aristocrazie albane rivolto ad antenati mitici comuni (si pensi alla leggendaria dinastia del Silvii e quindi intesa come una sorta di primitiva “regia” mitica) oppure alle divinità ctonie venerate sul Monte Albano prima di Giove Laziale. In tal modo, la complessa stratificazione dei miti albani, latini e infine romani, formatasi nel corso dei secoli, sembra comporsi e trovare un ordine, che possiamo riassumere schematicamente in vari momenti. Si tratta ovviamente di un ordine rudimentale, un primo passo in quello che sembra configurarsi come uno straordinario spazio d’indagine tutto da indagare, soprattutto con l’insostituibile ausilio di scavi futuri.
Iniziando dai miti albani relativi agli antenati, ai fondatori mitici, alle dinastie regali ecc., per poi proseguire con i leggendari re di Alba (in qualche modo sicuramente ascrivibili all’età arcaica o precedente) come Latino – divinizzato dopo la morte e successivamente venerato sull’adiacente mons Albanus come Iuppiter Latiaris, oppure attraverso racconti etruschizzanti di età arcaica come quello di Tarchezio “re di Alba” (VI sec. a.C.) prodotto nell’ambito dello sforzo egemonico dei Tarquini nel Lazio e sicuramente penetrato attraverso la parentela con Tuscolo. Si tratta di racconti che inaugurano la saga dei gemelli fondatori – ancora anonimi -, fatti uccidere e gettati in un fiume albano (probabilmente quello di Tuscolo), che dunque non fondano Roma ma probabilmente i principali centri di pianura (il che spiega il ruolo di Alba Longa intesa come fondatrice delle principali città latine).
Solo alla fine del III secolo a.C. si struttura definitivamente il mito di Alba Longa che conosciamo, ora intesa come antenata delle più importanti città da essa fondate nel Latium Vetus e la sua dimensione urbana (recintata da mura, con templi, edifici pubblici e strade) viene di conseguenza poiché scaturisce dalla necessità di postularne la fondazione in tempi antichissimi, in analogia con le città fondate da Roma.
(Sui “Re Antenati” e il culto dei Lari tra gli Albani in età pre-protostorica, vedi: http://www.osservatoriocollialbani.it/2022/05/26/i-re-di-alba-longa-la-dinastia-degli-antenati-mitici/)
(Su Tarchezio re di Alba vedi: Alba Longa e il suo fiume scomparso in: http://www.osservatoriocollialbani.it/2017/11/05/alba-alba-longa-tuscolo-e-il-suo-fiume-scomparso/)

![]()
INTERVENTO DI CARMINE AMPOLO
Il bel libro di Franco Arietti, Alba e il Monte Albano. Origine e sviluppo della Civiltà Albana, Tored 2020, costituisce un importante e significativo apporto agli studi su Alba Longa e sull’insieme di problemi archeologici e storici che si collegano al mondo “albano”, così importante per gli stessi Romani e per gli studi moderni sulle origini e di conseguenza sullo sviluppo di miti e leggende. Dopo il grande fervore di studi e pubblicazioni connesso alle scoperte di Lavinio da parte di Ferdinando Castagnoli e della sua scuola, è stata la volta del mondo albano. La grande raccolta di materiali nei due tomi di Alexandre Grandazzi, Alba Longa, Histoire d’une legende, Rome, BÉFAR 2008, aveva rappresentato una svolta, anche se discutibile in vari punti per la sua posizione contraddittoria: Alba Longa sarebbe insieme un mito perché sostanzialmente mai esistita come città eppure nello stesso tempo interpretata in modo tradizionalista, come qualcosa di precedente rispetto alla storiografia romana, con la lista dei popoli latina in Plinio considerata tutta antichissima e addirittura anteriore alla pretesa Roma di Romolo, ed estesa fino ai confini con l’Umbria (gli Olliculani sarebbero gli abitanti di Ocriculum!). In parte si assiste quasi ad un recupero di un passato non vicino, quello che emergeva con forza dagli studi di Niebuhr e Bachofen, così diversi ma spesso ignorati o non capiti dai moderni.
Arietti ci offre invece un quadro aggiornato della documentazione archeologica, allargata in più punti a quella storica ed epigrafica. E va dato pieno riconoscimento dei suoi meriti come editore e “salvatore” di importanti testimonianze della protostoria laziale, sempre dall’area dei Colli (cfr. Franco Arietti e Bruno Martellotta, La tomba principesca del Vivaro di Rocca di Papa, Roma 1998), come anche dello studio e della comprensione della via romana che portava al santuario principale dei Latini, pur servendo anche ville e aree di pertinenza di gentes come i Fabii. Sul basolato della strada romana, che ebbe varie fasi, è infatti incisa in più punti una V che sta per vetus, mentre sull’altro c’è la N che sta per novum, come riconobbe Theodor Mommsen e come Arietti ha confermato in un articolato quadro convincente di rifacimenti e allargamenti della strada.
Aggiungo di aver sempre apprezzato quanto ha fatto Arietti per la tutela e la sana valorizzazione dell’area.
La fioritura di studi sul Lazio, e in particolare sul Latium vetus e le sue città, ma anche sulle aree contermini e sui luoghi di culto, sta ponendo le premesse per una nuova comprensione del contesto storico dello sviluppo di Roma, dal X-IX secolo a.C. a tutta l’età repubblicana. Dalla famosa mostra “Civiltà del Lazio primitivo” a una serie notevole di convegni, seminari e mostre, gli archeologi e gli storici hanno potuto riproporre, tra ricerche, discussioni, e anche polemiche, problemi vecchi e nuovi. L’attenzione alla documentazione epigrafica laziale, spesso per merito degli allievi di Silvio Panciera, va anch’essa riconosciuta. In questa temperie va collocata l’opera di cui trattiamo qui. Ovviamente problemi storici centrali restano aperti, ma le basi conoscitive sono state spesso rinnovate dalla ricerca dopo i tempi di Andrea Alföldi, il cui Early Rome and the Latins è del 1963-1964, e delle polemiche che l’accompagnarono (si pensi agli studi di Arnaldo Momigliano). Anche le fonti letterarie, che restano con poche eccezioni quelle disponibili ai tempi di Niebuhr, sono riviste, in particolare per quel che riguarda le edizioni di storici di tradizione frammentaria; per tutte si veda quella degli storici latini edita dall’amico Tim Cornell. Ma anche testi sempre conosciuti sono stati rivisti grazie ad un’analisi rinnovata: nei recentissimi Studi in memoria di Alessandro Bedini si può leggere un saggio innovativo di Adriano La Regina che rivela come il noto Frutinal, il santuario di Venera Frutis, appartenesse in realtà a Venere Ericina! Anche dei relatori e relatrici di oggi hanno contribuito e contribuiscono a tale rinnovamento.
Per parte mia, devo rivendicare quanto anche in campo “albano” si possa fare evitando i rischi sia del tradizionalismo che dell’ipercritica, nel solco per così dire della “critica temperata”, cioè della posizione assunta da Gaetano De Sanctis agli inizi del XIX secolo a proposito delle liste di città, anzi di populi, del Lazio nel III libro di Plinio il Vecchio. Gli Albenses / Albani si rivelano come una comunità facente parte dei populi Latini, che partecipavano alle feriae sul Monte Albano e ricevevano quindi una porzione della carne delle vittime sacrificate – simbolo dell’essere parte giuridicamente e sacralmente del Nome Latino (nomen Latinum) –, ma scomparse o ritenute erroneamente tali. Non ritorno qui su questo punto essenziale, che consente di usare la lista di Plinio per quello che vi è compreso (anche insediamenti e comunità sui siti di Roma e del Latium vetus) senza troppe fantasie interpretative.
La concretezza del volume di Arietti ci richiama ai realia, ai dati di fatto, e non è piccolo merito.
Un punto su cui non mi trovo d’accordo con l’autore è quello della localizzazione di uno dei principali luoghi di riunione dei Latini in età arcaica e repubblicana, cioè il Lucus Ferentinae, il bosco sacro di Ferentina. Esso è stato variamente localizzato, talora anche per “patriottismo locale” (in un caso estremo persino molto più a Nord-Ovest di Roma!) e Arietti ritorna ad una identificazione tradizionale in territorio tuscolano; e vari studi recenti hanno arricchito il quadro delle ipotesi. Naturalmente non vi sono certezze e solo scoperte epigrafiche potranno dire in modo sicuro e preciso dove fosse: cosa non facile perché poteva trattarsi semplicemente di un’ampia radura nei boschi (secondo il significato originario del latino lucus) senza strutture monumentali. Ritorno altrove sul tema in modo analitico e ritengo, anche in base a fonti meno note, che esso fosse ubicato in un’area non lontana dal cd. Lago di Turno (Lacus Turni), il quale va certamente posto in un territorio che in età tardo- antica era di pertinenza di Albano e quindi sul versante sud dei Colli e non a Nord-Ovest. I racconti di storici e antiquari dell’antichità sui primordia hanno molto spesso una base topografica e toponomastica: ciò vale sia che si tratti di ricostruzioni erudite sia che sia descrizione di eventi reali. Si ricostruiva la battaglia mitica tra Sabini e Romani di Romolo nel foro in base a monumenti e nomi di luoghi e lo stesso vale per il Lazio mitistorico. L’unico racconto dettagliato di un raduno arcaico nel bosco di Ferentina era quello di Dionigi di Alicarnasso e un Turno Erdonio era ucciso gettandolo nell’acqua in un lago o simili.
Come spesso per gli antichi, i nomi sono conseguenza di azioni di personaggi, mitici o storici che siano: un Lago di Turno esisteva realmente in piena epoca storica e un Turnus gli aveva dato il nome, oppure il Turno reso celebre dall’Eneide di Virgilio o ancora il Turno Erdonio. Nel primo caso il luogo sarebbe nel territorio di Lavinio e dei Laurentes, nel secondo si tratterebbe del territorio in area albana, non sempre chiaramente delimitata rispetto ai centri latini vicini a causa dei cambiamenti. L’imperatore Tiberio, a dire di Cassio Dione, aveva trascorso un periodo nel “territorio tuscolano e albano”; la villa di Domiziano, sul lago di Castelgandolfo, è detta da Giovenale arx Albana, cioè arce o rocca albana. Insomma, l’aggettivo albano si applicava ad un’area più vasta e il mons Albanus è un cono vulcanico con più versanti, e il lucus può tranquillamente trovarsi su un versante diverso da quello tuscolano.
Ma questo è solo un aspetto non essenziale del libro di Arietti: l’importante è la rivalutazione del contesto generale, della documentazione sul Monte Albano. È un apporto sostanziale per il proseguimento della ricerca archeologica e storica sul Lazio e su Roma, di cui dobbiamo essere grati all’autore e all’editore.
![]()
INTERVENTO DI ANNA PASQUALINI
Alba Longa e i suoi dèi
La tradizione canonica vuole che da Alba sia iniziato il cammino di Roma verso l’eternità. È ad Alba che si consuma lo stupro divino di Rea Silvia; è ad Alba che sono nati i Gemelli e sono cresciuti dopo la cacciata di Amulio e la restituzione del trono a Numitore. Ad Alba s’impianta la dinastia dei Silvii. Nell’epico scontro tra i Curiazi Albani e gli Orazi Romani, Roma mostra ormai la sua supremazia e poco dopo distrugge Alba.
Tutto questo è leggenda.
Alba non è stata mai trovata. A nulla sono valsi gli sforzi di generazioni di studiosi, basti pensare che tra questi va annoverato Einrich Schliemann, lo scopritore di Troia, che non ebbe maggiore fortuna degli altri.
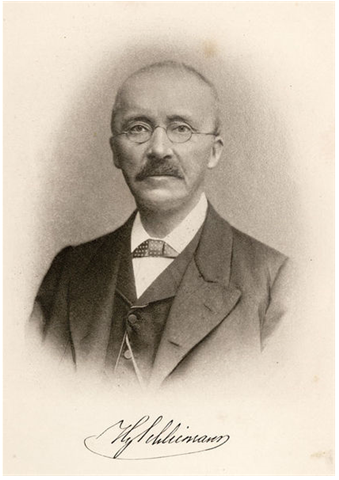
Alba non è stata trovata perché non è mai esistita; Alba è in realtà la capitale “mitica” del Nomen Latinum; essa è nata da una ricostruzione erudita che ha elaborato la preistoria di Roma per colmare un vuoto storiografico e per raccordare Enea a Romolo. Gli annalisti che si occuparono delle origini di Roma in nessun modo potevano giustificare i primordi dell’espansione romana nel Lazio senza un riferimento concreto. Essi non potevano ammettere che i popoli sparsi in villaggi intorno al lago Albano non avessero una capitale con templi, case e mura contro cui Roma avrebbe combattuto e vinto. Alba è il simbolo politico della mainmise di Roma sui Latini.
Ad un certo punto però, mentre la tradizione andava affinandosi e articolandosi in una affabulazione complessa, Alba fu individuata o meglio “collocata” nello spazio, secondo Franco, sul pianoro di Prato Fabio, e i suoi miti presero consistenza attraverso alcune istituzioni che sono definite “albane”, cioè riconducibili a una cultura “albana”.
Tra queste maggior rilievo hanno quelle religiose e, quindi, non sarà inutile passare in rassegna quei culti che fanno riferimento ad Alba.
Cominciamo ovviamente da Iuppiter Latiaris. Iuppiter Latiaris è il dio delle folgori che fulmina uno dei re di Alba, Allodio/Amulio, che messosi a fabbricare da mortale i fulmini è punito per la sua empietà. Il suo tempio, che sorgeva sulla cima più alta del Lazio oggi sconciata dai ripetitori, è praticamente sconosciuto.

Documenti d’archivio studiati da Claudia Cecamore e più diffusamente da Franco Arietti parlano di «grande quantità di marmi…, diversi idoli di metallo finissimo…, fantocci sì di uomini che di donne e di bestie,…cornici a fiorami, un dito di bronzo più che gigantesco, un piedistallo con sopra ambedue i piedi posati di una statua di marmo e molte, molte medaglie», e ancora di una statua di culto «mancante però della testa e che per l’ingiuria e la quantità dei secoli scorsi, fosse talmente scontraffata che poco o niente potevasi riconoscere», di varie cisterne; nel sopralluogo dell’Abate Riccy nel 1787 fu rinvenuto un blocco, parte forse del basamento del tempio con la scritta FULGUR che non compare nei corpora; una dedica in greco a Iuppiter Fulgurator , ora perduta, fu trovata a Palazzola (IG XIV 1118), gemella di quella dedicata a Efesto (IG XIV 1119), su cui tornerò. Nel 1869 e ad altri anni di poco successivi risale la scoperta dei frammenti dei Fasti feriarum Latinarum, che registrano, dal decemvirato legislativo in poi, le date e i nomi dei consoli che parteciparono alle Ferie Latine. Di tutto questo materiale si sono conservati solo i fasti suddetti; il resto è tutto scomparso.

Tutti sanno che in onore di Iuppiter Latiaris veniva celebrata la festa più importante dei popoli latini, caratterizzata dalla processione lungo la Via Sacra, qui vediamo Franco Arietti in una delle sue tante visite guidate e, al culmine delle celebrazioni, dall’immolazione del toro bianco (tra l’altro se non si aveva a disposizione un bue di quel colore se ne prendeva un altro e lo si ricopriva di biacca). Ogni comunità riceveva una parte delle carni secondo un ordine gerarchico rigidissimo. Roma dirigeva la festa che rimase in vita fino alla fine dell’antichità.

Le ferie, a cui prendevano parte i magistrati e i sacerdoti di tutte le città latine ammesse al rito, con a capo i consoli di Roma, assunsero da subito la funzione di fissare per sempre la supremazia di Roma sui Latini; nonostante l’apparente piede di parità, il rapporto, in realtà, era squilibrato avendo come interlocutori Roma, da sola, da una parte, e i Latini, tutti insieme, dall’altra.
Sull’arce albana Giove Laziale non regnava da solo. Le fonti dicono che accanto al tempio del dio sovrano fu dedicato nel 168 un tempio a Giunone Moneta dal pretore Cicereius che lo aveva promesso 15 anni prima per una vittoria sui Corsi. Non sappiamo nulla dei motivi che indussero il magistrato ad un gesto simile, bizzarro, se vogliamo, certamente legato alla sua devozione per una dea latina per eccellenza e forse a un intervento oracolare della stessa. Ora, questo accostamento di Iuppiter a Iuno Moneta riproduce parte della topografia sacra del Campidoglio, dove, accanto al grande tempio della triade, fu eretto già verso la fine del VI sec. un sacello a quella dea Moneta, ammonitrice, protettrice delle rocche, che svolgerà un ruolo determinante in occasione dell’incendio gallico, suscitando lo strepito delle celebri oche.

Alla presenza di Giunone sull’arx Albana allude anche Virgilio quando immagina che la dea scruti dall’alto i preparativi dello scontro finale tra Enea e Turno. Non a caso Giunone è dea dei Latini nemica di Enea e i versi virgiliani non fanno che accentuare la “latinità” di Monte Cavo.
Secondo Lucano un gran fuoco, attinto all’ara di Vesta, concludeva la celebrazione delle ferie latine. Vesta, in effetti, dea del focolare e della comunità civile, e per estensione dello Stato, non poteva non essere venerata dal nomen Latinum, che si riconosceva nel suo più antico e prestigioso santuario. Inoltre Livio afferma espressamente che quello delle Vestali è Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. Rea Silvia è considerata la prima Vestale della storia (leggendaria) e la prima a essere condannata per l’incesto con Marte. La leggenda ha generato un solido filone iconografico, con Marte armato di tutto punto che plana su Rea Silvia addormentata e inconsapevole; qui propongo il celebre quadro pompeiano dalla casa di Fabio Secondo (DIA 8, 9, 10).



Leggenda appunto, ma la leggenda, che per gli antichi è storia, ha prodotto istituzioni religiose concrete. A Marte, com’è noto, sono legati i Salii, i preti danzanti che a Roma all’apertura della stagione della guerra portano in processione gli ancilia, i 12 scudi di Marte, anzi in realtà un solo scudo, quello caduto dal cielo, perché gli altri 11 sono repliche perfette foggiate per confondere eventuali ladri. Ma, oltre a quelli urbani, sono documentati Salii in alcune città latine; due iscrizioni documentano salii Albani (CIL VI 2170, XIV 2947), di cui purtroppo sfuggono le funzioni, come in genere per tutti quelli che recano un epiteto derivato dal nome di una città.
In questa bella lapide, ora ai Musei Vaticani, sono rappresentati due personaggi dai tratti estremamente veristici, volti di persone che potremmo incontrare anche oggi. Lui, con patronimico e tribù, appartiene alla gens Antistia, illustre e diffusa nel Lazio, mentre lei è sua liberta e compagna di vita. Antistio non ricoprì alcuna carica pubblica se non quella di sacerdote del collegio dei salii albani, di cui fu anche magister. Andava sul Monte a rievocare la divina paternità di Marte, come sembrerebbe suggerire la probabile presenza dei Salii nel citato quadro di Fabio Secondo, i quali indicano la scena dell’incontro tra il dio e Rea Silvia, oppure apriva anch’egli la stagione della guerra della comunità romano-latina? E la apriva eseguendo la consueta danza rituale con risonar di scudi come sembrerebbe confermare un accenno di Nigidio Figulo, riportato da Nonio (de prop. serm. 183 = 58 L), derivato forse a sua volta dal commento al carmen saliare di Elio Stilone, maestro di Varrone: TINTINNIRE dicitur sonare…Nigidius lib. XVIII itaque ex aere in Saliaribus adtanus (Albanus?) «tintinat», id est «sonat», dove Albanus, che è correzione di Giusto Lipsio in luogo dell’incomprensibile adtanus, indicherebbe il Monte Albano.


Molto più consistente è la documentazione sulle Vestali albane: esse compaiono su due documenti epigrafici (CIL XIV 2140; VI 2172): uno molto interessante proveniente da Boville. Si tratta del fianco resecato di una base onoraria (la fronte è andata perduta) posta nel 158 d.C. forse a L. Manlio Severo, che fu a Boville “sindaco” della città e rex sacrorum; a questi fu concesso di porre il ritratto su un clipeo della sorella, Manlia Severina, vergine vestale massima (di Boville) davanti a un tempio “nuovo”, di cui non sappiamo nulla, né del nuovo né del vecchio.
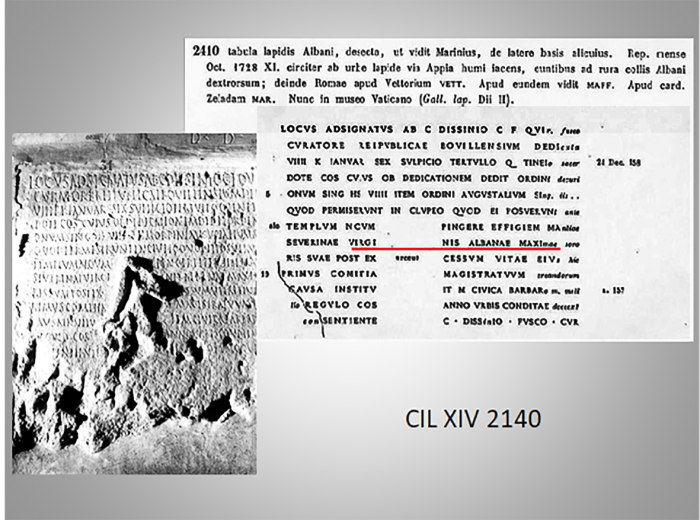
Anche le fonti letterarie parlano di vergini albane in due occasioni: la testimonianza più antica e interessante proviene dal commento di Asconio alla pro Milone di Cicerone, in cui si dice che al processo per la morte di Clodio furono sentiti testimoni di Bovillae, dove era avvenuto l’omicidio, e tra questi furono sentite le Vergini Albane; esse riferirono che una donna sconosciuta era andata presso di loro per sciogliere un voto (formulato) per ordine di Milone, affinché Clodio fosse ucciso.
L’ultima attestazione di una Vestale Albana è datata poco prima del 382 e si trova in due lettere di Simmaco. Vi si esamina il caso di una Primigenia quae sacra Albana curabat che, rea confessa, si era macchiata del crimine di incesto con un certo Massimo. Nelle lettere si discute chi dovesse condannarla, ma a noi questo interessa poco. È notevole invece che il sacerdozio albano fosse ancora così vitale ancora alla fine del IV secolo. Cosa facessero poi è tutto da scoprire, se mai sarà possibile: preparavano la mola salsa per il sacrificio, accendevano il fuoco sacro a Vesta? Non lo sapremo mai.
Forse solo tardivamente, a seguito della devozione di Domiziano, compare nel territorio di Alba la dea Minerva, in onore della quale l’imperatore istituì feste (caccie di cui era appassionato), ludi scenici e gare di poesia e oratoria; egli impose anche che i Quinquatria, feste tipiche di Minerva celebrate il 19 marzo, giorno natalizio della dea protettrice delle arti e dell’oratoria, si svolgessero nella sua villa sulle sponde del lago, il sontuosissimo Albanum su cui sorge l’altrettanto sontuosa Villa Pontificia.
Il culto dei Penati, dèi collettivi assimilati a volte con i Lari, ha un aggancio interessante con Alba e merita un accenno: narra Dionisio di Alicarnasso che «Trent’anni dopo la fondazione di Lavinio, Ascanio figlio di Enea costruì, come era stato predetto dall’oracolo un’altra città, in cui trasferì tutti quelli di Lavinio e di altre città latine che erano desiderosi di una sede migliore; alla città impose il nome di Alba… Si racconta che all’ epoca della fondazione della città avvenne un grandissimo prodigio; una volta completata la costruzione di un tempio e di un santuario destinato ad accogliere le immagini degli dèi che Enea aveva portato con sé da Troia e collocato a Lavinio, vi si trasferirono da quest’ultima città i sacri simulacri. Ma la notte successiva, nonostante che le porte fossero rimaste chiuse e i muri e il tetto non recassero tracce di effrazione, si trovò che le statue avevano mutato posto ed erano tornate sopra i vecchi basamenti. Benché fossero state là riportate da Lavinio, in mezzo a supplicazioni e sacrifici propiziatori, ritornarono comunque nello stesso luogo. Per qualche tempo gli abitanti rimasero perplessi su come dovessero comportarsi, perché non intendevano vivere lontani dai loro dèi patrii e neppure fare ritorno nella sede appena abbandonata; alla fine ricorsero a un espediente che doveva soddisfare entrambe queste esigenze. Le sacre immagini le lasciarono dov’erano, e gli uomini che avevano il compito di prendersene cura dovevano ritrasferirsi da Alba a Lavinio… I Romani chiamano Penati questi loro dèi...»
Questo andirivieni di Penati, che caparbiamente vogliono restare a Lavinio, come capita anche a molte nostre Madonne, è il riflesso mitico della competizione politica tra Roma e i Latini; Alba tenta di imporsi su Lavinio, sede dei sacra principia p. R. Quiritium nominisque Latini, quai apud Laurentes coluntur, come leggiamo in una famosa iscrizione (CIL X 797), dove peraltro Romani e Latini condividono ormai gli stessi principia. Gli Albani, cioè i Latini, rivendicano i Penati, gli eroi fondatori, per affermare la priorità dei loro principia. Ma il tentativo fallisce. La leggenda, che ha certamente una funzione ideologica, sembra essere stata elaborata da fonte filolatina, in velata polemica con Roma.
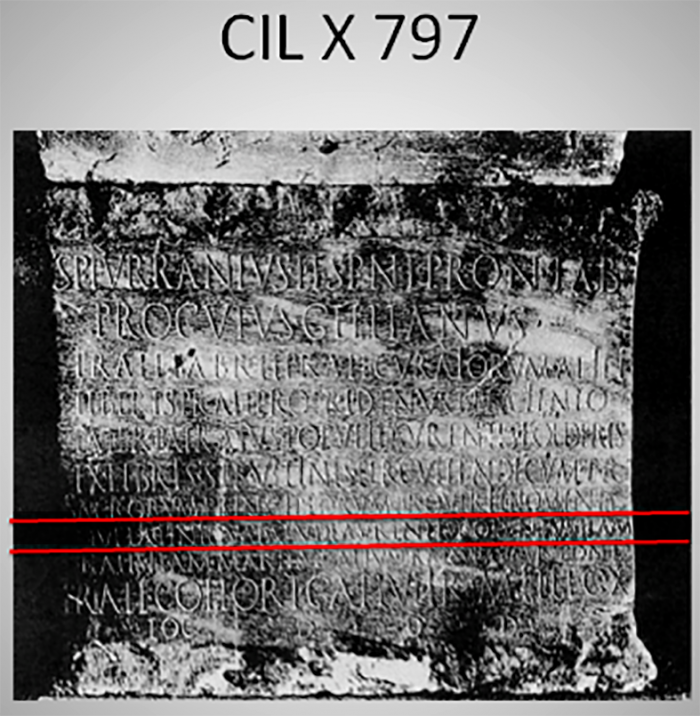
Quanto alla liturgia in onore degli dèi fondatori, oltre al generico Fauno (schol. Cic.), che viene sempre chiamato in causa quando si tratta di primordi, non può essere sottovalutata la dedica già menzionata a Efesto (Vulcano). Il dio, avido di vittime umane sostituite da pisciculi, è responsabile sotto la veste di fuoco sacro della nascita di Romolo e di Servio Tullio ed è legato strettamente alle saghe delle origini. Anche ad Alba veniva offerto il piscatorium aes menzionato da Festo (p. 230 L)[1]: Piscatorium aes vetusto more appellatur, quod in Albano monte datur pro piscibus); secondo la Cecamore il piscatorium aes costituirebbe una stips albana per Vulcano simile a quella del Volcanal di Roma. In effetti è stato rinvenuto nel sito una gran quantità di aes rude (non coniato) che confermerebbe il dato di Festo, ma potrebbe trattarsi anche di un rito in favore della pesca lacustre (così ad es. Le Gall e recentemente Braconi).
Prima di concludere vorrei tornare ancora un momento a Iuppiter Latiaris e alla divinità sovrana del Monte. Tempo fa ebbi occasione di avanzare un’ipotesi che ha avuto scarsa attenzione, ma che mi sembra ancora oggi degna di essere riproposta.
Tutti conoscono la grande ara rinvenuta a Boville eretta dalla gens Iulia a Vediovis pater.

Sappiamo anche che Boville era considerata erede dei sacra di Alba. Non per nulla i suoi abitanti si chiamavano Albani Longani Bovillenses. I Giuli inoltre proclamavano un’origo albana e a Boville sorse ad opera di Tiberio un sacrario della gens Iulia.
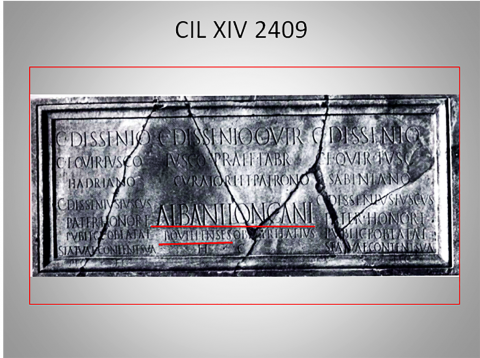
Ora perché mai i Giuli, eredi dei sacra di Alba, sono devoti a Veiove e non a Iuppiter? E chi è Veiove? Si tratta di una divinità locale nota solo, guarda caso, a Lavinio, a Boville e a Roma. A Lavinio nella zona dei celebri altari sono stati trovati due bronzetti che sono stati unanimemente riferiti a Veiove.

A Roma Veiove ha ben due templi uno sull’Isola Tiberina, dedicato nel 194, e un altro sul Campidoglio, dedicato appena due anni dopo nel 192, e dotato già dal 193, a detta di Plinio, di una statua di culto in cipresso. Un fortunato caso ha voluto si rinvenissero negli anni ’30 il basamento del tempio e la statua di culto della fase tardo repubblicana o augustea.

La natura del dio, benevola o malvagia, fu oggetto di controversia già in antico: per quanto riguarda l’aspetto Ovidio (Fasti III 437 s.) afferma che il dio: Iupiter est iuvenis… fulmina nulla tenet… stat quoque capra simul e prosegue ricordando la capra Amaltea che nutrì Giove fanciullo; Gellio (V, 12), parlando della statua di culto, dice: sagittas tenet, quae sunt videlicet partae ad nocendum. Quapropter eum deum plerumque Apollinem dixerunt immolaturque ritu humano capra, eiusque animalis figmentum iuxta simulacrum stat. Quindi suoi attributi peculiari, con accentuati caratteri ctonii, sono la giovinezza, le frecce e la capra. Per alcuni autori è dio benevolo protettore dei fuggiaschi e titolare dell’asylum di Romolo, per altri è nume infernale simile a Dite, tanto che, a detta di Macrobio (III, 9, 10), viene invocato nel rito della devotio che serve a distruggere città e eserciti nemici. Il richiamo a Dite e il collegamento con i miti albani sono rafforzati da un dettaglio poco valorizzato e cioè dalla oscillatio[2] che si praticava durante le Ferie e su cui ci informa, tra gli altri, Festo (p. 212 L), il quale collega l’uso alla ricerca, attraverso il movimento delle altalene, del re Latino, “scomparso” come tutti i bravi fondatori. Servio Danielino aggiunge alla fine della lunga glossa che riguarda gli oscilla menzionati da Virgilio (georg. II 389) che gli oscilla sono detti così perché capita et ora delle vittime venivano fissate su alte pertiche Ora, capita et ora rimandano inequivocabilmente alla notizia di Macrobio secondo la quale i Pelasgi stanziatisi nel Lazio «eressero un tempietto a Dite e un altare a Saturno. Per molto tempo ritennero di dover sacrificare teste umane a Dite e immolare uomini a Saturno». In seguito Ercole consigliò loro di offrire a Dite non hominum capita sed oscilla ad humanam effigiem arte simulata, et aras Saturnias non mactando viro sed accensis luminibus «non teste umane, ma statuette riproducenti le fattezze umane, e venerando gli altari di Saturno non con l’immolazione di un uomo ma con lumi accesi». Sappiamo inoltre che durante le Ferie Latine di Roma veniva sacrificato un bestiarius (un condannato a morte che dall’arena veniva dirottato al sacello di Iuppiter Latiaris, il cui sangue serviva ad irrorare la statua del dio). Non è escluso che un tale rito fosse praticato in origine anche sul Monte Albano. Comunque sia Dite e suo padre Saturno sono dèi ctonii e connessi con i sacrifici umani, non estranei, per altro, alla società romana.
Io ritengo, quindi, che Veiove, assimilato a Dis pater (e quindi a Saturno), a cui si sacrificava una capra ritu humano, cioè in sostituzione di un sacrificio umano, dalle valenze ctonie in sintonia con i culti di eroi fondatori, abbia buone probabilità di essere il titolare ab origine delle feste dei Latini sul Monte Albano. In tempi più maturi a Veiove pater si sostituì Iuppiter come accadde a Lavinio dove al pater Indiges si sovrappose Iuppiter Indiges poi assimilato a Enea. Veiove però continuò a essere venerato dai Giuli che ne assunsero la custodia e ne tramandarono il culto, un culto però locale e privato, ben lontano da quello sovrano delle origini.
A dirigere e a indirizzare codesto complesso Pantheon albano era preposto, non si sa da quale data, un Pontefice, il ‘canonista’ per eccellenza della religione romana.
Vale la pena di soffermarci, a questo proposito, su una base onoraria di Ostia datata al 249 d.C. posta ad un cavaliere della colonia, promosso centenario per la sua religiosa disciplina, che all’età di 28 anni, ‘per primo’, ricoprì la carica di Pontifex et dictator Albanus.
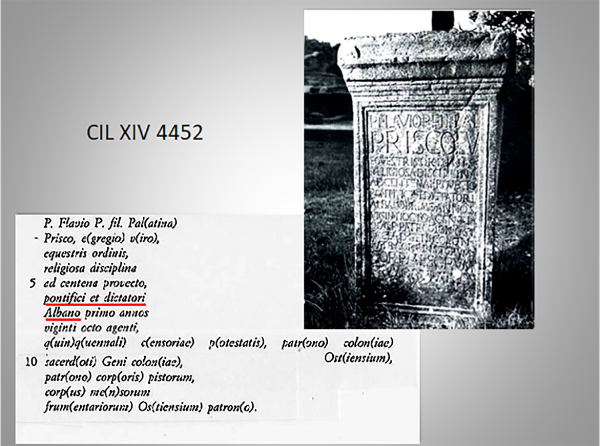
Il documento è estremamente suggestivo perché testimonia come alla metà del III secolo, epoca in cui fu eretto il monumento, istituzioni che si ritenevano “albane” fossero ancora vitali. Come pontifex Flavio Prisco avrà avuto la direzione dei sacra Albana in analogia con le funzioni dei pontefici romani, mentre da dictator, ridotto ad sacra, avrà rappresentato, putacaso alle Ferie Latine, la leadership dei populi Albani. Certo la connessione tra pontificato e dittatura albani richiama il nesso tra dittatura e pontificato di Cesare, peculiare della sua ideologia e funzionale alla sua propaganda. Forse l’istituzione del sacerdozio albano, ma questa è un’ipotesi che va vagliata e che vi espongo con tutte le cautele del caso, va attribuita all’opera di Augusto restauratore dei culti del Lazio, ispirata a sua volta alla politica religiosa di suo padre Cesare.
Non a caso la fortuna ha voluto che il primo pontefice albano di cui si abbia notizia sia Lucio Memmio, forse imparentato con il console del 31 d.C., Memmio Regolo, che aveva una villa ad Ariccia; il nostro fu senatore e ricoprì importanti incarichi ai tempi di Cesare e Augusto. Il rango del personaggio, un senatore appunto, suggerisce che egli sia divenuto pontefice albano poco prima che Augusto regolamentasse la materia dei sacerdozi “latini” e li affidasse all’ordine dei cavalieri. L’importanza dell’incarico è sottolineata dalla posizione che esso ha nell’impaginazione del testo epigrafico.
Nell’ordo sacerdotum, superiore al pontifex e a tutti gli altri collegi sacerdotali, al primo posto si trovava il rex sacrorum, le cui funzioni sembrano legate al tempo e al calendario liturgico; ebbene da Boville, erede, come detto più volte dei sacra Albana, proviene un epitaffio posto a Lucio Manlio Severo, padre o fratello di quella Manlia Severina, Vestale albana, che ebbe l’onore del clipeo dipinto con la sua effige, già menzionata; ebbene costui fu rex sacrorum, fictor del collegio dei pontefici di Roma (cioè incaricato della confezione delle focacce usate nei sacrifici dai pontefici e dalle vergini vestali) e quattuorviro di Boville. Si discute se questi sia sacerdote di Roma oppure di Boville. A mio giudizio non si può escludere né l’una né l’altra ipotesi, anche se la documentazione sui reges sacr. urbani sembra arrestarsi alla prima età imperiale e qui siamo all’epoca di Antonino Pio, ma è anche vero che quell’epoca fu caratterizzata da un forte revival delle tradizioni più antiche e più in particolare di quelle legate alle origini di Roma, compreso il Lazio.
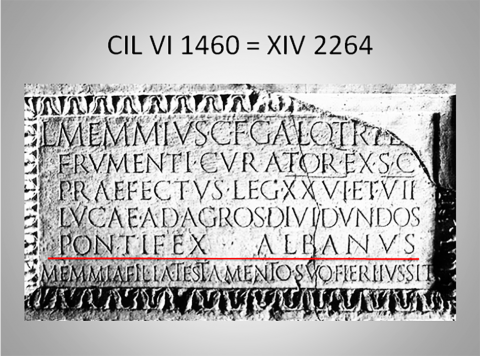

In sostanza, per riassumere, possiamo dire che ad un certo periodo, non sappiamo quando, ma già in epoca tardo-repubblicana, come mostrano il processo di Milone nel 52 a.C. e il pontificato albano del senatore cesariano-augusteo L. Memmio, si costruì intorno al mito albano, sempre vitale ma valorizzato da Cesare (Zecchini, Cesare e il mos maiorum), una liturgia “albana” officiata da un corpo sacerdotale articolato, per dare spessore concreto alla leggenda. L’iniziativa ebbe successo perché di sacerdoti albani e del culto di Iuppiter Latiaris si continuò a parlare fino alla tarda antichità.
[1] P. Braconi, Dall’aes piscatorium all’anulus piscatoris. Vulcano, i pesci e il romanzo del fuoco nell’acqua, in Vestigia. Miscellanea di studi storico-religiosi in onore di Filippo Coarelli nel suo 80° compleanno, a cura di V. Gasparini, Stuttgart 2016, pp. 107-118.
[2] Sull’oscillatio cfr. E. Roscini, Gli oscilla e l’oscillatio presso i Romani: fonti antiche e terminologia archeologica a confronto, in «ScAnt» 19, 2013, pp. 233-257.
![]()
INTERVENTO DI VERONICA CIMINO – SINDACA DI ROCCA DI PAPA
Ringrazio per l’invito l’Università di Tor Vergata e mi congratulo per l’organizzazione di questo importante evento, e rivolgo un ringraziamento particolare al Dott. Arietti per l’impegno profuso sia nella ricerca che nella tutela del territorio di Rocca di Papa.
Abbiamo assistito ad un dibattito scientifico in cui, oltre alla presentazione delle nuove straordinarie scoperte archeologiche, è emersa la necessità di risolvere il problema della vergognosa devastazione di Monte Cavo.
Il tema, ampiamente dibattuto oggi, ha evidenziato il Complesso sacrale del Monte Albano attorno al quale si estende, fino alle sue pendici, il Bosco Sacro di Giove, presso cui è stato identificato il luogo dove gli antichi credettero fosse realmente esistita la “città” di Alba Longa, la cui memoria – come scoperto di recente – i Romani celebravano sul promontorio di Prato Fabio. La Via Sacra, che diventa tale quando nell’ultimo tratto attraversa il Bosco Sacro, è costellata da iscrizioni incise sui basoli, un unicum nel mondo romano; essa collegava pertanto i due monumenti tra i più insigni dell’antichità, posti uno accanto all’altro: Alba Longa e il Santuario federale dei popoli latini posto sulla vetta del Monte Albano.
Da oltre trent’anni quest’area ha sistematicamente patito una devastazione definita recentemente da studiosi d’oltralpe “uno scandalo di dimensioni europee”. Sono stati compiuti infatti una serie di gravissimi illeciti – solo in parte accertati e condannati dalle sentenze della magistratura – la cui portata travalica di gran lunga il delitto di Disastro ambientale, come previsto dal Codice Penale, L. 68/2015. Ciò avviene ed è avvenuto nel corso degli ultimi decenni, arrecando danni gravissimi alla Storia antica, attraverso la distruzione dei luoghi che hanno visto nascere la Civiltà Latina, forse irrimediabilmente perduti sia a livello archeologico che ambientale, a causa di opere, anche militari, che hanno profondamente rimodellato, stravolto e definitivamente modificato la morfologia originale del Monte Albano – esso stesso un monumento da preservare e tutelare nella sua piena integrità.
Tutti i vincoli storici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e urbanistici apposti per la protezione di quest’area, giudicata di straordinario valore e interesse in ogni ambito istituzionale o scientifico, sono stati ignorati, così come le cinque interrogazioni e interpellanze parlamentari, tutte cadute nel vuoto. Lo stesso vale per le ordinanze di demolizione comunali e le conseguenti sentenze di condanna della magistratura giunte all’ultimo grado di giudizio che hanno respinto tutti gli appelli, ordinando l’immediata demolizione delle opere abusive entro limiti di tempo prestabiliti. Ciò finora non è avvenuto, confidando soprattutto nell’assoluta impossibilità di procedere in tal senso dal Comune di Rocca di Papa, il quale – purtroppo lasciato solo da tutte le istituzioni pubbliche coinvolte – avrebbe dovuto anticipare enormi spese attraverso un indebitamento insostenibile e, nel contempo, affrontare problemi tecnici assolutamente estranei alle proprie capacità e competenze.
Per queste ragioni si è costituito il Comitato promotore di una Legge per il Monte Albano – al quale la scrivente Amministrazione ha aderito per prima – il quale ha rivolto un appello ai sedici comuni del Colli Albani, alle università italiane ed estere, ai principali Istituti di indirizzo storico archeologico e a tutte le accademie ed istituzioni straniere attive in campo storico archeologico con sede a Roma.
Le numerose adesioni che stanno giungendo, testimoniano la grande preoccupazione e la volontà del mondo della cultura di porre fine a questa vergognosa condizione in cui versa il luogo dov’è nata la Civiltà Latina. Per questa ragione, il Comitato promotore della Legge per il Monte Albano terrà in autunno una conferenza stampa presso l’Associazione della Stampa estera in Roma, chiedendo alle istituzioni europee di intervenire per salvare il luogo che ha generato le origini comuni e quindi la fratellanza dei popoli europei che viene richiamata in ogni trattato.
![]()